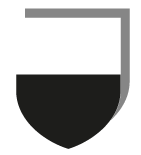Schede di Trasformazione
POLO ABBADIA RENACCIO- DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO - ATI N. 10
SEZIONE I - Profili generali dell'intervento
1.1 Obiettivi generali
L'ATI Abbadia-Renaccio, rappresenta un perno fondamentale della Città dell'Arbia, collocandosi come elemento di snodo tra gli agglomerati di Taverne d'Arbia e di Abbadia, in prevalenza a carattere residenziale, e l'area produttiva di Renaccio. Questa scelta insediativa si affida in misura significativa alla realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali di rilevanti dimensioni, che fanno leva da un lato sulla possibilità di valorizzare, con una nuova stazione, l'incrocio delle linee ferroviarie Siena-Chiusi e Siena Grosseto, e dall'altro sul completamento di alcuni interventi di potenziamento della viabilità (collegamento con Taverne d'Arbia).
Gli obiettivi "qualitativi" del nuovo insediamento dovranno assicurare non solo la creazione di aree di aggregazione di tipo urbano, ma anche la configurazione di una forma urbana che consente di coniugare l'inserimento armonioso in un paesaggio agrario di buona qualità e l'ottenimento di prestazioni insediative in grado di competere con l'offerta abitativa presente in contesti territoriali meno periferici. Punti di forza dovranno essere pertanto:
- - l'inserimento in una rete efficiente di trasporti pubblici e privati, centrato sulla nuova stazione;
- - la ricca dotazione di percorsi pedonali e ciclabili, adeguatamente separati dalla mobilità veicolare, e in grado di garantire un contatto diretto degli abitanti con la natura;
- - la presenza di una centralità di livello urbano, e di dotazioni urbanistiche adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
- - la previsione di fasce di ambientazione atte a garantire l'abbattimento delle principali forme di inquinamento acustico, atmosferico e paesaggistico;
- - l'individuazione di una matrice insediativa in grado di garantire elevate prestazioni energetiche e ambientali (soleggiamento, ventilazione, recupero delle acque meteoriche, ecc.).
Coerentemente con questi obiettivi di carattere generale l'intervento sarà attuato tramite PCI che consentirà all'Amministrazione comunale di adottare una formula attuativa tale da assicurare una efficace regia al percorso che si svilupperà negli anni a venire, e che consentirà di gestire efficacemente e in modo trasparente l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati. Inoltre la procedura negoziale e integrata che in questo modo verrà promossa servirà ad assicurare il controllo degli esiti percettivi, sia "interni" che "esterni", in particolare sul fronte verso Asciano, ricorrendo ad una progettazione a grande scala che prima di concentrarsi sulle singole componenti provveda ad assicurare la qualità urbana dell'intero organismo.
Seguendo questa strategia sarà possibile garantire altresì che la Città dell'Arbia non venga interpretata come un episodio estemporaneo di diffusione insediativa, ma come un insieme unitario e formalmente compiuto di urbanizzazione contemporanea.
1.2 Ambito territoriale e unità di intervento
Sotto il profilo territoriale, l'intervento complesso di Abbadia-Renaccio sarà concepito non come un insediamento isolato e chiuso in sé, bensì in una logica di integrazione con gli insediamenti limitrofi, ed in particolare con il nucleo di Abbadia, con Taverne d'Arbia e con Arbia (Asciano).
Gli assetti finali da perseguire garantiranno, oltre alla complementarietà tra il nuovo e l'esistente, un rafforzamento qualitativo e quantitativo di quello che diverrà il polo settentrionale della città dell'Arbia, con conseguente incremento generalizzato della dotazione di servizi, di effetto urbano, di accessibilità a Siena.
La diversa conformazione dell'area, più accidentata ed elevata nella porzione a nord, dove si concentra il tessuto preesistente e più pianeggiante nella parte meridionale, dove insistono invece preesistenze puntuali di pregio, quali la fattoria di Renaccio, evidenzia le diverse vocazioni territoriali e la necessità di prevedere diverse modalità e approcci progettuali. Pertanto se il PCI e l'insieme delle opere di carattere pubblico sono da considerarsi in modo unitario per i suddetti motivi l'intero ambito è suddiviso in 3 unità minime di intervento, rispettivamente "l'Abbadia" a nord (Intervento 1), "la Stazione" (Intervento 2), nella parte centrale (suddivisa in 2 comparti rispettivamente 2.1 e 2.2) e "Renaccio" (Intervento 3), per le quali saranno perseguiti obiettivi e garantite prestazioni specifiche. Per quanto riguarda l'unità minima di intervento "la Stazione" (2), nel comparto 2.1 è consentito l'intervento edilizio diretto per la realizzazione di residenze a carattere sociale, ed attività commerciali e servizi (Tc ed S) solo nel caso in cui l'area possa beneficiare di finanziamenti pubblici derivanti dalla partecipazione a procedure concorsuali riguardanti previsioni del RU inerenti le aree ricomprese nel PCI.
SEZIONE II - Riferimenti quantitativi
2.1 Dimensionamento complessivo e delle singole unità di intervento
Nell'ATI di Abbadia-Renaccio è da realizzarsi un insediamento prevalentemente residenziale per circa 404 alloggi (abitanti virtuali 939) comprensivo di esercizi di vicinato e di terziario (uffici, studi professionali, servizi alla persona) nella misura massima dell'8% della SUL residenziale proposta. Tale ultima quantità dovrà essere distribuita all'interno dei singoli Interventi in modo proporzionale alla SUL. Nell'intervento 2 tale percentuale è stata localizzata in un lotto specifico in continuità con quello della scuola, mentre negli altri interventi la stessa potrà essere reperita al piano terra degli edifici, in prossimità delle aree di uso pubblico.
Si rammenta che l'art. 134 c. 2 delle NTA del PS riserva non meno del 50% della produzione di nuove residenze ad alloggi con finalità sociali, da suddividere secondo i criteri generali definiti dalle seguenti quote:
- - 20% della capacità edificatoria globale alla residenza in locazione a canone concertato per la durata di almeno 20 anni;
- - 20% della capacità edificatoria globale all'edilizia residenziale convenzionata;
- - 10% della capacità edificatoria globale all'edilizia residenziale sovvenzionata.
La progettazione dell'insediamento dovrà garantire l'integrazione delle diverse forme edilizie - quella libera e quella con finalità sociale - al fine di favorire processi e fenomeni di inclusione. A tal fine sarà necessario porre particolare attenzione alla progettazione del sistema degli spazi pubblici e all'uso di tipologie compatibili.
Il dimensionamento dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella seguenti tabelle, che sono da considerarsi prescrittive.
La Superficie Fondiaria max espressa nelle seguenti tabelle, attiene esclusivamente alle aree di Concentrazione volumetrica; sono escluse da tale valore, le superfici, pur di pertinenza degli immobili, necessarie per strade, parcheggi e verde.
| Superficie | Unità mis. | |
|---|---|---|
| Superficie Territoriale | 263.120 | mq |
| Dotazioni Pubbliche min | 99.290 | mq |
| Verde privato min | 102.315 | mq |
| Superficie Fondiaria max | 61.515 | mq |
| Superficie | Unità mis. | |
|---|---|---|
| Viabilità principale (Mz) (compresa pista ciclabile) | 13.390 | mq |
| Viabilità locale (Ma) | 2.825 | mq |
| Mobilità pedonale (Mh) | 15.810 | mq |
| Parcheggio di cui al D.M. 1444/'68 (Mbr) | 4.695 | mq |
| Parcheggio di relazione (Mbr) | 17.050 | mq |
| Verde attrezzato (Va) | 33.315 | mq |
| Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) | 935 | mq |
| Servizi per l'istruzione di base (Sb) | 2.410 | mq |
| Servizi tecnici e tecnologici (Sm) | 65 | mq |
| Impianti sportivi all'aperto (So) | 8.425 | mq |
| Stazione passeggeri (Me) | 370 | mq |
| Superficie | Unità mis. | |
|---|---|---|
| Verde complementare (Vc) | 5.205 | mq |
| Verde di ambientazione (Vd) | 32.840 | mq |
| Verde agricolo in ambito urbano (Ve) | 64.270 | mq |
| Superficie | Unità mis. | |
|---|---|---|
| Superficie Fondiaria max | 61.515 | mq |
| Macro lotti max | 26 | n. |
| Superficie Utile Lorda residenziale max | 30.990 | mq |
| di cui libera | 15.495 | mq |
| di cui a carattere sociale | 15.495 | mq |
| Edifici max | 40 | n. |
| Alloggi max | 404 | n. |
| di cui a carattere sociale min | 202 | n. |
| Superficie Utile Lorda direzionale, commerciale e/o esercizio pubblico max 8% della SUL residenziale | 2.480 | mq |
| Piani fuori terra max | 4 | n. |
| Piani interrati o seminterrati max | 1 | n. |
| Superficie | Unità mis. | |
|---|---|---|
| Intervento 1 - "L'ABBADIA" | ||
| Superficie Fondiaria max | 11.015 | mq |
| Superficie Utile Lorda residenziale max | 3.725 | mq |
| Edifici max | 11 | n. |
| Alloggi max | 48 | n. |
| di cui a carattere sociale min | 23 | n. |
| Tipologia | bi e tri-familiari linea, blocco e linea | |
| Piani fuori terra max | 3 | n. |
| Piani interrati o seminterrati max | 1 | n. |
| Altezza max | 10,7 | m |
| Tipo di intervento | Subordinato all'approvazione del PCI | |
| Intervento 2.1 - "LA STAZIONE" | ||
| Superficie Fondiaria max | 15.560 | mq |
| Superficie Utile Lorda residenziale max | 10.205 | mq |
| Alloggi max | 136 | n. |
| di cui a carattere sociale min | 152 | n. |
| Superficie Utile Lorda servizi per l'istruzione di base (Sb) | 1.000 | mq |
| Superficie Utile Lorda servizi/centro civico polivalente (S) | 300 | mq |
| Edifici max | 9 | n. |
| Tipologia | linea e blocco | |
| Piani fuori terra max | 4 | n. |
| Piani interrati o seminterrati max | 1 | n. |
| Altezza max a valle | 14,7 | m |
| Tipo di intervento | Intervento edilizio diretto | |
| Intervento 2.2 - "LA STAZIONE" | ||
| Superficie Fondiaria max | 22.260 | mq |
| Superficie Utile Lorda residenziale max | 10.205 | mq |
| Edifici max | 13 | n. |
| Alloggi max | 131 | n. |
| Tipologia | linea, blocco, tri e quadri-familiari | |
| Piani fuori terra max | 4 | n. |
| Piani interrati o seminterrati max | 1 | n. |
| Altezza max a valle | 14,7 | m |
| Tipo di intervento | Subordinato all'approvazione del PCI | |
| Intervento 3 - "RENACCIO" | ||
| Superficie Fondiaria max | 12.680 | mq |
| Superficie Utile Lorda residenziale max | 6.855 | mq |
| Edifici max | 7 | n. |
| Alloggi max | 89 | n. |
| di cui a carattere sociale min | 43 | n. |
| Tipologia | linea e blocco | |
| Piani fuori terra max | 4 | n. |
| Piani interrati o seminterrati max | 1 | n. |
| Altezza max a valle | 14,7 | m |
| Tipo di intervento | Subordinato all'approvazione del PCI | |
SEZIONE III - Dotazioni pubbliche e di verde privato da garantire: prescrizioni
3.1 Prescrizioni per dotazioni pubbliche e infrastrutturali
L'intervento comprenderà la realizzazione di:
- - L'accesso al nuovo insediamento, in particolare quello della "Stazione" e di "Renaccio" sarà garantito dalla rotatoria esistente a nord e da quella di progetto a sud, in prossimità del BSA Fattoria Renaccio, che distribuirà il traffico veicolare sia della zona artigianale esistente che del nuovo insediamento residenziale; nella progettazione della nuova rotatoria dovrà essere preservata l'ingresso storico alla Fattoria e il relativo sistema vegetazionale (presenza di lecci storici);
- - Una connessione viaria con Taverne d'Arbia, con innesto nella rotatoria esistente, prevedendo il sottopasso della linea ferroviaria Siena-Buonconvento ed il ponte sul torrente Bozzone; la connessione sarà affiancata da un collegamento ciclo pedonale protetto;
- - Un sistema della viabilità dotato di una fascia attrezzata con alberature, adeguato al sistema della sosta, ai percorsi ciclo-pedonali, agli spazi per le stazioni ecologiche opportunamente mitigati e alle pensiline del sistema del TPL integrate con l'insieme dell'arredo urbano e dotate di sistemi di captazione dell'energia solare. La viabilità locale (Ma) ed il sistema della sosta (Mbr), che si dirama da quella principale (Mz), privata di uso pubblico, potrà essere conteggiata ai fini della permeabilità dei suoli, di cui al D.C.R.T N. 230/1994, per una quota non superiore al 50% della quantità da garantire in ciascun lotto edificabile;
- - Un sistema della sosta di superficie che dovrà prevedere soluzioni lungo strada e aree specifiche destinate a parcheggio per le quali si richiedono soluzioni atte a mitigare la visibilità e l'impatto degli auto-veicoli nel contesto; è opportuno prevedere l'uso di tecnologie che garantiscano la permeabilità dei suoli e l'uso integrato di essenze vegetali; ad integrazione delle alberature potranno essere previste delle strutture leggere (legno metallo etc.) quale copertura degli autoveicoli e sede di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- - Un sistema parco esteso all'intero ambito, caratterizzato da una rete di percorsi, piccole aree di sosta/relax in relazione con le residenze, da spazi aperti per attività ludico-sportive (campi polivalenti, bocciodromo, rampa skateboard, percorsi salute etc.) dotati anche di idonee strutture destinate a spogliatoi etc..(queste dovranno costituire elemento di arredo favorendo l'uso di strutture leggere parzialmente prefabbricate in legno vetro e metallo e l'integrazione di sistemi di captazione dell'energia solare) e da un'area più ampia in relazione con la centralità pubblica;
- - Nella realizzazione delle trasformazioni è da prevedersi, con modalità compatibili con lo svolgimento delle attività di cantiere, l'impianto anticipato della vegetazione arborea di progetto (pre-verdissement);
- - Una stazione ferroviaria su due livelli in relazione alla contestuale attivazione della Metropolitana leggera. L'edificio, di piccole dimensioni dovrà garantire il collegamento tra le 2 linee ferroviarie (Siena - Buonconvento - Monte Antico e Siena - Chiusi) e prevedere una passerella/banchina; la struttura sarà dotata di sala d'attesa chiusa e di spazi coperti;
- - Una centralità da localizzare in prossimità della stazione ferroviaria dove dovranno essere collocate le principali funzioni pubbliche e di servizio. Tra le funzioni si prevede: attività commerciali di vicinato, servizi alla persona e un complesso integrato di edifici pubblici da destinarsi ad Asilo nido, Scuola d'infanzia (da valutare in relazione alla struttura esistente "la Pimpa") e a Centro civico polivalente; quest'ultimo dovrà garantire un'accessibilità e connessione pubblica tra la piazza interna e il sistema di spazi di ingresso all'insediamento (area di sosta e piazzale) rispettando l'allineamento con il sovrappasso pedonale. È preferibile una soluzione architettonica che preveda porticati al piano terra, in aderenza ai confini del lotto, che garantisca un ampliamento della piazza ed un'adeguata permeabilità dello spazio pubblico.
3.2 Temi progettuali specifici: prestazioni
3.2.1 L'inserimento nel contesto paesaggistico
Sarà oggetto di particolare attenzione l'inserimento nel contesto paesaggistico, ed in particolare nell'ambito percettivo delle valli dell'Arbia e del Bozzone, anche attraverso la concezione di un assetto insediativo che garantisca:
- - la permeabilità fisico-percettiva trasversale al crinale (direzione est-ovest) mediante fasce di verde pubblico, privato e di percorsi di attraversamento prevalentemente pedonali che rappresentano la continuità tra paesaggio urbano e rurale e che divengono nuovi elementi di paesaggio;
- - il corretto equilibrio in termini dimensionali tra il costruito ed il paesaggio, ponendo attenzione ai fronti che si affacciano sul crinale ad ovest e sul versante est; in particolare si dovrà realizzare rispettivamente un fronte più compatto, costruito ed omogeneo lungo strada interna, dove saranno collocati gli edifici più alti, creando un "effetto città", e un fronte più articolato, aperto e meno denso verso valle, riducendo l'impatto del costruito sul contesto ambientale e favorendo l'integrazione tra il paesaggio rurale preesistente e quello urbano di nuova realizzazione;
- - la presenza di un sistema integrato di aree verdi con un diverso grado di naturalità, con differente fruibilità e vari livelli di attrezzature evitando la percezione di una saldatura urbana e mantenendo i caratteri di ruralità del contesto ambientale di riferimento; è preferibile limitare l'inserimento di elementi tipici dell'arredo urbano;
- - le aree a Verde agricolo in ambito urbano (Ve) dovranno prevedere l'impianto di filari di essenze arboree autoctone (in particolare ulivi) a compensazione della superficie di nuova urbanizzazione; in particolare nell'intervento dell'"Abbadia" il nuovo impianto dovrà integrare quello esistente di ulivi, preservando il più possibile quelle esistenti.
Il sistema delle aree verdi – alberature lungo strada, parcheggi, verde pubblico, verde di ambientazione, verde complementare – sarà oggetto di un progetto unitario di paesaggio che, sulla base delle indicazioni del DM 16.01.1974 e del PIT paesaggistico (sub ambito 33c, sezione 3 e 4) e delle tavole B.8.2.04 e B.8.2.05 del PS, articoli le differenti componenti al fine di:
- ripristinare nell'area di fondovalle tra la ferrovia e il corso del Bozzone un lembo di bosco ripariale ai fini specifici di rinaturalizzazione e conservazione della biodiversità (obiettivi 14.5. e 19.5. scheda paesaggio ambito 33c PIT);
- ampliare le superfici a bosco, in una logica di connessione con i boschi esistenti;
- dotare di alberi di alto fusto le aree di verde pubblico e le aree più accessibili di verde di ambientazione;
- valorizzare le aree di verde pubblico come elementi di discontinuità evitando l'effetto di delimitazione del contesto costruito ed ambientale mantenendo i caratteri di ruralità;
- progettare i margini degli insediamenti in modo da raccordarli al contesto, alternando piccole aree di bosco, uliveti, spazi aperti in corrispondenza di visuali significative (obiettivi 6.1., 6.2. e 6.4. scheda paesaggio ambito 33c sez. 3 PIT);
- coordinare il disegno e la composizione della vegetazione urbana (viali, parcheggi) al disegno dei margini (obiettivo 19.4 scheda paesaggio ambito 33c sez. 3 PIT).
Il progetto di paesaggio sarà corredato da uno specifico programma di gestione da includere nei dispositivi convenzionali.
3.2.2 Gli spazi di relazione
Attraverso gli spazi di relazione ed aggregazione si dovrà garantire un sistema complesso di connessioni tra la centralità di quartiere -dove saranno organizzate le attività di servizio e le funzioni pubbliche- ed il tessuto insediativo, da concepire in una logica di integrazione diffusa tra spazi pubblici e privati, valorizzando la dimensione di vicinato (percorsi ciclo-pedonali, aree di relax, etc.) e garantendo una ampia accessibilità pedonale.
3.2.3 Il sistema dei percorsi
Particolare attenzione deve essere posta al sistema integrato dei percorsi carrabili e ciclo-pedonali garantendo la circolarità dei flussi ed il collegamento tra le parti nord e sud dell'insediamento, in particolare nella parte nord nell'intervento 2.2 sono previsti 3 percorsi pedonali di uso pubblico, il primo lungo strada da ricavare nella fascia di verde di ambientazione o all'interno dei lotti, uno a valle in prossimità del verde pubblico attrezzato e l'ultimo lungo la ferrovia in continuità con quello proveniente dall'intervento 1. Inoltre dovrà essere previsto un adeguato collegamento con il sistema dei percorsi ciclabili di ambito provinciale, quali la Poggibonsi-Buonconvento, la valorizzazione dei percorsi storici esistenti (cfr tav. C.5/01 Invarianti Strutturali del PS) e la realizzazione della connessione con l'abitato di Taverne d'Arbia.
3.2.4 Il rapporto con l'insediamento esistente
Particolare attenzione sarà posta al dialogo con l'edificato esistente e precisamente con la presenza puntuale di alcuni nuclei storici (Fattoria e Podere Renaccio) nella parte sud dell'ambito (Interventi 2 e 3) e con il tessuto preesistente di recente formazione nella parte nord dove emergono alcuni beni storici (Villa Andreina e l'Abbadia) che dovranno essere valorizzati migliorandone il rapporto con lo spazio pubblico e le relazioni con l'insediamento in termini di percorsi ed accessibilità. In tal senso l'intervento nella parte a nord dovrà tener conto della consistenza planivolumetrica e della trama dell'edificato esistente, dare spessore e continuità al tessuto attualmente frammentato e garantire prestazioni di tipo urbano, quali l'illuminazione e i percorsi pedonali protetti che vadano a ricucire l'intera area.
SEZIONE IV - Prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi edilizi
4.1 Temi progettuali specifici: prescrizioni
4.1.1 Prescrizioni progettuali dell'impianto urbano
Il disegno del nuovo impianto urbano dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- - Scelta di una maglia insediativa che garantisca la massima disponibilità solare e minimo ombreggiamento;
- - Gli edifici dovranno avere esposizione Sud, Sud-Est e Sud-Ovest e comunque la migliore esposizione calcolata in situ;
- - Il tessuto dovrà essere opportunamente arretrato rispetto alla viabilità, in particolare nell'intervento 2.1 dovrà essere rispettata la distanza di 30 m dal binario prevedendo in tale fascia, all'interno dei lotti, un'ampia area boscata ad integrazione di quella prevista lungo la linea ferroviaria;
- - Contenimento dell'inquinamento luminoso con la dotazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia;
- - Posizionamento di sistemi di verde e di opportune schermature per fronteggiare il soleggiamento nel periodo estivo;
- - E' opportuno sfruttare la morfologia del terreno esistente per ridurre lo sviluppo delle rampe di accesso alle auto-rimesse interrate e garantire la relativa aerazione; in tal senso è necessario prevedere piastre funzionali per garage, cantine e locali tecnici; sono preferibili piastre unitarie per più blocchi residenziali, al fine di ridurre gli ingressi, le rampe di accesso, ottimizzare e massimizzare gli spazi di servizio e quelli annessi alle abitazioni;
- - I parcheggi per la sosta stanziale di cui all'art. 40 delle NTA relativi all'edilizia convenzionata potranno essere reperiti per una quota non superiore al 25% nelle aree a parcheggio a raso di uso pubblico (Mbr).
- - Gli spazi di relazione che sono previsti nell'area della "Stazione" (Intervento 2) e dell'"Abbadia" (Intervento 1) dovranno prevedere zone permeabili attrezzate con essenze vegetali, siepi, alberature, aree a prato per una quota non inferiore al 20% della superficie totale; l'obiettivo è infatti quello di arricchire l'articolazione degli spazi pubblici e di favorire l'inserimento di elementi naturali all'interno dello spazio costruito delimitando piccole aree di sosta di relazione e percorsi pedonali;
- - I percorsi pedonali protetti dovranno integrare l'uso di materiali naturali e permeabili, essere opportunamente ombreggiati con essenze arboree autoctone e dotati di arredi urbani uniformi e contestualizzati; in particolare il sovrappasso pedonale previsto sulla viabilità di collegamento con Taverne dovrà privilegiare l'uso di strutture leggere, anche parzialmente prefabbricate, in metallo e legno.
4.1.2 Prescrizioni progettuali tipologiche e costruttive
Gli edifici dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- - Sviluppo prevalentemente orizzontale con tipologie in linea di dimensioni contenute, favorendo l'articolazione volumetrica (min. 2, max 4 piani) e una discontinuità dei fabbricati mirata a favorire la permeabilità fisico-percettiva trasversale nord-sud;
- - Le coperture potranno essere sia a falda che in piano, in questo ultimo caso dovranno ospitare un manto erboso praticabile (tetto giardino) che potrà essere comunque parzialmente pavimentato (terrazzo) ed ospitare impianti per la captazione dell'energia solare;
- - Valorizzazione dei sistemi solari passivi (muro di Trombe, serre, camini, schermature etc.);
- - Dotazione di impianti che utilizzino: fonti rinnovabili di energia, tecnologie di micro e cogenerazione e reti duali (raccolta separata delle acque grigie e nere);
- - Recupero delle acque meteoriche e di quelle bianche in genere al fine del riuso in ambito privato e pubblico previa la dotazione degli opportuni impianti di depurazione;
- - Gli impianti per la captazione dell'energia solare dovranno essere integrati con la progettazione architettonica;
- - La dotazione di spazi terrazzati abitabili (aperti e/o semi aperti, logge etc.) funzionali all'articolazione volumetrica e ai sistemi di schermatura e ombreggiamento estivo;
- - Nell'unità di intervento 1 "l'Abbadia", considerato il tessuto circostante, caratterizzato da piccole unità residenziali, sono consentite anche tipologie a blocco e unità bi-familiari e tri-familiari;
- Nell'unità di intervento 2.2 "la stazione", considerata la morfologia del terreno lungo la strada dell'Abbadia, caratterizzata da elevata acclività e discontinuità, sono consentite anche tipologie tri-familiari e quadri-familiari;
- - Sarà garantito l'uso di sistemi costruttivi, anche prefabbricati, basati su materiali eco-compatibili, facilmente riciclabili, su tecnologie innovative, che garantiscono il contenimento energetico, la durabilità nel tempo e ridotti tempi di esecuzione;
- - In particolare per le opere di sostegno dovranno essere privilegiati sistemi naturali ed eco-compatibili quali terre armate a faccia verde etc.
SEZIONE V - Gli effetti attesi
5.1 Gli effetti ambientali
L'intervento prevede l'edificazione di un numero consistente di alloggi e di servizi nonché di infrastrutture lineari (la strada di collegamento con Taverne d'Arbia) e puntuali (la nuova stazione multilivello) e dunque comporterà un consistente consumo di suolo, comunque in massima parte a fini abitativi (l'intervento si avvantaggia di infrastrutture già realizzate, essendo dotato di buona accessibilità)
Come previsto dal PS per tutti gli interventi che comportano l'artificializzazione dei suoli, sono previste misure compensative tese ad incrementare la naturalità di determinati luoghi (aree di bosco di nuovo impianto).
Lo sviluppo coerente delle indicazioni progettuali contenute nel precedente par. 2 indirizza comunque verso un uso oculato dei suoli da urbanizzare, evitando la realizzazione di ampie aree di urbanizzato continuo.
5.2 Gli effetti paesaggistici
I nuovi insediamenti ricadono in massima parte nel sottosistema dei Paesaggi collinari delle Crete d'Arbia e avranno una matrice di crinale/versante: non saranno comunque investite da trasformazioni edilizie ed urbanistiche parti significative di tessiture agrarie di pregio.
Sotto il profilo di inserimento nel paesaggio, l'obiettivo principale posto dai requisiti progettuali -atteso che vi sarà comunque una consistente sostituzione di paesaggi rurali con paesaggi prettamente urbani - è quello di evitare la formazione di un fronte costruito eccessivamente compatto, che avrebbe un impatto paesaggistico elevato soprattutto per le visuali dai versanti in sinistra idrografica dell'Arbia verso Siena.
La infrastruttura di collegamento con Taverne d'Arbia e una parte delle compensazioni ambientali (realizzazione del nuovo bosco) interesseranno anche il sistema dei Paesaggi di fondovalle, ma in questo caso sarà più agevole perseguire un equilibrio soddisfacente tra trasformazione e riqualificazione, a patto di utilizzare convenientemente i materiali progettuali.
5.3 Gli effetti socio-economici e insediativi
L'intervento di Abbadia-Renaccio si propone di soddisfare la domanda di abitazioni sia di costo medio che di costo contenuto, proponendone un mix integrato.
Rispetto agli interventi insediativi condotti nel recente passato, prevalentemente collocati nelle immediate vicinanze del centro abitato di Siena, l'insediamento di Abbadia-Renaccio offrirà condizioni abitative maggiormente integrate con il contesto rurale, garantendo comunque una agevole accessibilità al capoluogo ed una dotazione di servizi elevata, risultante dalle sinergie attivabili con Taverne d'Arbia e Arbia.
Per i nuovi insediamenti non appaiono dunque consistenti i rischi di isolamento di carenza di servizi essenziali, mentre effetti positivi di incremento dell'effetto città sono da attendersi per gli insediamenti limitrofi.
Le attenzioni progettuali suggerite (orientamento degli edifici, risparmio energetico, abbondanza di spazi verdi, attenzione alla mobilità ciclopedonale) sono suscettibili di proporre un nuovo modo di abitare che si ritiene possa essere particolarmente attrattivo per le fasce giovanili.


 Schema progettuale
Schema progettuale
SEZIONE VI la valutazione: livelli di coerenza della trasformazione con i riferimenti vigenti (PS, PTC, Codice dei Beni Culturali)
| Prestazioni richieste | Valutazione di coerenza | |
|---|---|---|
| 1 Caratteri del Piano | ||
| 1.1 Idea di città | All'Art. 19 il PS definisce i propri principi ordinatori; tra questi risulta l'obiettivo di perseguire una società urbana più inclusiva in grado di migliorare le opportunità di abitare la città e il territorio; | A |
| 1.2 Compensazione ambientale | Per gli interventi di trasformazione urbanistica soggetti a piani attuativi o a PCI, che prevedono nuovi consumi di suolo il PS prevede all'Art. 32 interventi di compensazione ambientale. Il RU definisce gli aspetti quantitativi e qualitativi delle compensazioni stesse, assicurando una equivalenza tra superfici da urbanizzare e superfici da rinaturalizzare. | A |
| 1.3 Piano Regolatore delle cittine e dei cittini | Nella progettazione delle trasformazioni inerenti il Sistema Funzionale della Città e degli Insediamenti Il PS prevede: Art.35, il soddisfacimento delle esigenze espresse attraverso il PRC2, ed in particolare: la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi pedonali di collegamento tra i differenti plessi scolastici e tra i plessi scolastici e le aree verdi, la disponibilità di campi di gioco fruibili in maniera diretta da bambini, ragazzi ed adulti e di luoghi di aggregazione all'aperto dedicati agli adolescenti, la disponibilità di impianti sportivi e di palestre, l'attuazione di misure di moderazione del traffico veicolare in prossimità degli ingressi dei plessi scolastici, eventualmente modulate in funzione degli orari di ingresso e di uscita. |
A |
| 2 Componente strategica | ||
| 2.1 UTOE N. 9 - Città dell'Arbia - Strategia di sviluppo territoriale | La "Città dell'Arbia" è assurta a polo urbano di assoluto rilievo per l'entità degli interventi previsti, e per la qualità della progettazione integrata che si vuole sviluppare, attraverso una serie di interventi che interconnettano fisicamente e funzionalmente i centri di Taverne, Abbadia e Isola e le aree industriali di Isola e Renaccio. In particolare, nei centri di Taverne, Abbadia, il PS intende completare e riqualificare i tessuti esistenti attraverso l'inserimento di nuove quote di edificato in aderenza o prossimità agli attuali perimetri urbani, la riprogettazione degli spazi pubblici e il miglioramento della qualità degli arredi urbani e delle urbanizzazioni. L'aumento dell'offerta abitativa persegue una maggiore articolazione della struttura sociale, attraverso l'inserimento di quote di edilizia sociale, per anziani e studenti. Il livello di mobilità viene migliorato attraverso la realizzazione della metropolitana leggera, lo sviluppo dell'intermodalità nei pressi delle nuove stazioni della metropolitana di superficie. Il parco fluviale dell'Arbia diventa invece il luogo privilegiato della mobilità leggera, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili che interconnettono gli insediamenti. Tra questi, assume particolare rilievo la pista ciclabile Poggibonsi-Buonconvento, che attraversa tutta l'UTOE. Infine, il PS persegue l'adeguamento del sistema della depurazione a Isola, al confine con il nucleo di Ponte a Tressa. |
A |
| 2.2 UTOE N 9 - azioni | L'incremento residenziale nel quadrante sud-est del comune di Siena, in particolare nelle frazioni di Taverne e Isola, viene perseguito attraverso la realizzazione di circa 1270 alloggi, distribuiti principalmente tra le frazioni di Isola e Taverne e nell'ambito del nuovo polo multifunzionale gravitante attorno alla stazione di Isola Scalo. Il RU e il PGTU, nell'ambito delle loro attribuzioni, individuano le nuove fermate della metropolitana leggera nelle zone di Ruffolo e Taverne, nel punto di incrocio tra le linee Siena-Chiusi e Siena-Buonconvento, ad Isola. In prossimità di tali fermate sono previste aree per la sosta e nuovi parcheggi scambiatori, oltre all'integrazione con il sistema del TPL. |
A |
| 3 Componente statutaria | ||
| 3.1 Invarianti | Il PS prevede: Art. 39. La via Francigena ed i percorsi storici 1. I percorsi selezionati nella Tav. C5.01, sono rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio senese, nonché espressione attuale di elevati livelli di armonia ed equilibrio con i contesti paesaggistici attraversati. 2. Le prestazioni non negoziabili sono costituite:
4. Le aree di sosta sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto. 5. Le piste ciclabili sono realizzate utilizzando il sedime stradale esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti. Art. 40. Le forme insediative di crinale e le emergenze insediative del territorio aperto 1. Le forme insediative di crinale e le emergenze evidenziate nella Tav. C5.01 sono da mantenersi in quanto espressive delle relazioni consolidate tra viabilità, beni storico-architettonici e tessiture agrarie del promiscuo nei paesaggi collinari senesi. Gli Statuti delle risorse ed il RU fissano gli obiettivi e la disciplina necessaria per garantire le prestazioni di cui al co. 1, curando in particolare le modalità della nuova edificazione, la integrità fisica degli edifici storici e le modalità di ripristino dei paesaggi agrari intimamente legati agli edifici stessi. |
A |
| 3.2.1 Lo statuto dell'aria (Inquinamento luminoso) | Il PS prevede: Art. 45, l'assunzione degli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del contenimento delle emissioni luminose verso l'alto contenuti nella legge reg. Toscana 21 marzo 2000, n. 37. Art. 151. nella la redazione del Piano Comunale per l'illuminazione Pubblica (PCIP) e del contenimento dell'inquinamento luminoso nelle ATI vengono applicati i criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna contenuti nella legge reg. Toscana n. 39/2005 recante "Disposizioni in materia di energia". Seguono le principali prescrizioni.
|
A |
| 3.2.2 Lo statuto dell'aria (Inquinamento acustico) | Il prevede: Art. 46, il mantenimento delle soglie di attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 30 maggio 2000; Art. 49, la verifica del comfort acustico nelle trasformazioni urbanistiche; in particolare le aree interessate da nuove edificazioni in attuazione dei RU sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico In particolare l'area di intervento rientra per la maggior parte nella classe IV (aree di intensa attività umana) e per una porzione a sud in prossimità dell'insediamento produttivo nella classe V (aree prevalentemente industriali). |
A |
| 3.3.1 Lo statuto dell'acqua (Vulnerabilità degli acquiferi) | Il PS per gli interventi che ricadono in aree sensibili di classe 2 prevede: Art. 54, azioni volte alla limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti dovute a attività antropiche. |
A |
| 3.3.2 Lo statuto dell'acqua (Pericolosità idraulica) | Il PS per gli interventi che ricadono in area con classe di pericolosità irrilevante prevede all'Art. 61 che non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico. | A |
| 3.3.3 Lo statuto del suolo (pericolosità geologica) | Il PS per gli interventi che ricadono in area con pericolosità geologica bassa, che definisce come situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili, prevede: Art. 68, indagini geognostiche di supporto alla progettazione edilizia Nella parte a nord è localizzata un'area, non interessata da interventi di urbanizzazione, che risulta in classe 3 (media). |
A |
| 3.4.1 Lo statuto degli ecosistemi e del paesaggio (Sistema di Paesaggio di Fondovalle) | Il PS per gli interventi, che ricadono nel Sistema di Paesaggio di Fondovalle, Sottosistema delle pianure alluvionali, prevede: Art. 72, il contenimento dell'incremento dei suoli artificiali, la previsione per le nuove urbanizzazioni di densità insediative medio-alte e il recupero delle aree e degli edifici dismessi; a compensazione dei processi di trasformazione integrata la creazione di aree pubbliche o aree aperte alla fruizione pubblica; Art. 76, come misura di compensazione per le aree interessate da interventi di trasformazione integrata l'impianto di una superficie a bosco la cui estensione è stabilita dal RU. |
A |
| 3.5.1.a Lo statuto della città e degli insediamenti (Sistema di Paesaggio delle Crete) | Art. 73. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio delle Crete e relativi sottosistemi 1. Il PS assume quali obiettivi per l'intero sistema di Paesaggio delle Crete:
Le aree di trasformazione integrata che prevedono nuove occupazioni di suolo sono individuate dal RU esclusivamente in aderenza o prossimità di insediamenti esistenti, privilegiando il riuso di aree già urbanizzate. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate nel rispetto della misura di compensazione per le aree di nuova urbanizzazione nelle quali è da prevedersi l'impianto di una superficie a bosco la cui estensione è stabilita dal RU. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi delle Crete, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie gli interventi di: - restringimento della maglia dei campi, limitandone l'estensione unitaria ad un massimo di 15 ha; - ripristino delle colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici; - creazione di boschetti autoctoni isolati in posizione di crinale; - incremento della vegetazione naturale negli impluvi, da ottenersi arretrando le arature e le semine di almeno 5 m da ogni lato dell'impluvio e non disturbando l'affermazione dei processi evolutivi naturali. |
A |
| 3.5.1.b Lo statuto della città e degli insediamenti (Sistema di Paesaggio di Fondovalle e relativi Sottosistemi) | Art. 72. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio di Fondovalle e relativi Sottosistemi 1. Il PS assume quali obiettivi prestazionali per l'intero Sistema del Paesaggio di Fondovalle:
Art. 76. La disciplina per il Sistema dei Paesaggi di Fondovalle 1. Le aree di trasformazione ricadenti nei Paesaggi di Fondovalle sono individuate dal RU privilegiando, a parità di requisiti funzionali, le aree che presentano uno o più dei seguenti requisiti:
6. Gli interventi di restauro e recupero ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi di Fondovalle, promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie il miglioramento della continuità ambientale e l'incremento della consistenza della vegetazione igrofila, nonché l'aumento della consistenza boschiva e della vegetazione autoctona lungo le divisioni dei campi. 7. Il RU definisce nello specifico le tipologie, i materiali e le dimensioni delle strutture precarie o degli annessi suscettibili di riqualificazione o di eliminazione. |
A |
| 3.5.2.a Lo statuto della città e degli insediamenti (Filamenti del Territorio Aperto) | Il PS per gli interventi, che ricadono nel Sottosistema dei Filamenti del Territorio Aperto, prevede: Art. 86. Obiettivi per il Sottosistema dei Filamenti del Territorio Aperto 1. Il Sottosistema dei Filamenti del Territorio Aperto comprende insediamenti a bassa densità sviluppatisi lungo i percorsi storici di crinale con funzioni originarie di organizzazione e gestione dell'attività agricola, così come indicati dalla Tav. C.5.04. 2. Il PS assume per questo sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il RU disciplina le differenti componenti del sottosistema dei filamenti di territorio aperto, così come individuati nella Tav. C.5.04. sulla base dei contenuti dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, nonché in funzione della disciplina dei beni storico-architettonici del territorio aperto, curando che la eventuale previsione di addizioni edilizie non comporti estesi fenomeni di saldatura |
A |
| 3.5.2.b Lo statuto della città e degli insediamenti (Insediamento Rurale Diffuso) | Art. 87. Obiettivi per il sottosistema dell'Insediamento Rurale Diffuso 1. Il sottosistema dell'Insediamento Rurale Diffuso ricomprende sia insediamenti a struttura complessa, caratterizzati da forte articolazione e specializzazione tipologica e funzionale dell'edificato e degli spazi aperti (Monteliscai), sia insediamenti elementari isolati - storici e recenti - diffusi sul territorio. 2. Sono compresi in questo sottosistema gli insediamenti diffusi nel territorio aperto che non formano sistemi di insediamenti riconoscibili o riconducibili ai filamenti del territorio aperto di cui al precedente art. 86. 3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:
1. Il RU disciplina il sottosistema dell'insediamento rurale diffuso, così come individuati nella Tav. C.5.0.4. sia sulla base degli obiettivi di cui all'art. 87 delle NTA che, sulla base dei contenuti dello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio, nonché in funzione della disciplina dei beni storico-architettonici del territorio aperto. 2. L'eventuale concessione di aumenti di volumetria in edifici di valore storico nullo è subordinata alla eliminazione di eventuali elementi in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi (annessi precari, recinzioni) o comunque alla previsione di interventi di miglioramento ambientale coerenti con le indicazioni dello Statuto degli ecosistemi del paesaggio. |
A |
| 3.5.2.c Lo statuto della città e degli insediamenti Sezione II. I criteri di gestione generali | Art. 94. Disciplina per i beni storico architettonici del territorio aperto - trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resede: prescrizioni per il RU 1. Il RU disciplina le trasformazioni ammesse nelle aree di pertinenza e nei resede dei BSA sulla base delle seguenti prescrizioni:
|
A |
| 4 Vincoli | ||
| Vincolo paesaggistico | L'intervento rientra tra le aree di notevole interesse pubblico soggette a particolari procedure di controllo, gestione e tutela, così come definito dal D.lgs 42 anno 2004, art 136, Parte III; in particolare si fa riferimento al Decreto ministeriale del 16-01-1974 (G.U. n. 58 del 2 marzo 1974). | A |
SEZIONE VII - Fattibilità
Scheda grafica della fattibilitàDal punto di vista idraulico l'intervento in oggetto ricade quasi totalmente in classe di pericolosità 1, pertanto si attribuisce una fattibilità senza particolari limitazioni I.1 a tutti gli interventi ricadenti in essa.
La zona in prossimità del Torrente Bozzone ricade in classi di pericolosità 3 e 4, ma dato che la destinazione di tale superficie sarà a verde si attribuisce una fattibilità senza particolari limitazioni I.1.
Il settore settentrionale della zona di intervento ricade in parte in area sensibile di classe 2 relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi. Pertanto si ritiene opportuno verificare, attraverso una campagna di indagine idrogeologica e litostratigrafica, l'effettiva presenza di una falda entro profondità significative. I risultati dell'indagine dovranno essere utilizzati, in sede di Piano Attuativo, per calibrare le eventuali misure precauzionali tese a limitare la possibile propagazione di elementi inquinanti entro le falde presenti, così come previsto dall'Art. 164 delle NTA.
Dal punto di vista geomorfologico, nella parte centrale dell'area di trasformazione, denominata 10.2, è presente una zona perimetrata in classe 3 (PFE), dovuta sia alla presenza di terreni argillosi in una zona a maggiore pendenza del versante. Pertanto per le aree con previsione a superficie fondiaria che intersecano la classe 3 di pericolosità geomorfologica, si attribuisce una fattibilità condizionata G.3. Ciò significa che in fase di predisposizione del Piano Attuativo dovranno essere acquisiti dei parametri stratigrafici e geotecnici dei terreni interessati dall'intervento e dovrà essere eseguita una verifica di stabilità del versante interessato da pericolosità elevata.
Ai percorsi pedonali ed alle aree con destinazione a verde che rientrano in classe 3 di pericolosità si attribuisce una fattibilità senza particolari limitazioni G.1.
La restante superficie dell'ATI 10 ricade in classe di pericolosità geomorfologica 2, quindi si attribuisce una fattibilità con normali vincoli G.2 nelle zone di previsione degli edifici, dei parcheggi a raso e della viabilità locale. Alle aree a verde ed ai percorsi pedonali si attribuisce una fattibilità G.1.
Relativamente all'aspetto sismico, essendo l'area in classe di pericolosità 3, nella zona di previsione degli edifici e della viabilità locale, si attribuisce fattibilità S3, ovvero dovrà essere eseguita una campagna di indagini geofisiche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche al fine di valutare il contrasto di rigidità sismica tra i terreni di copertura e bedrock sismico. Ai parcheggi scoperti è attribuita fattibilità sismica S2, mentre alla mobilità pedonale è attribuita fattibilità sismica S1.