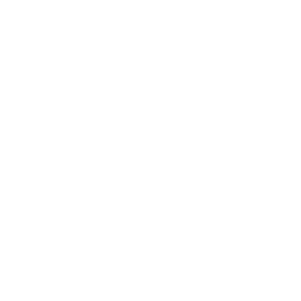Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Titolo VI: NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE
CAPO 1 Le Fonti energetiche rinnovabili
Art. 53. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Per l'autorizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.
2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.
3. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:
in base alla collocazione:
- - fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
- - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
- - fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra;
in base alle finalità produttive:
- - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte dell'energia che produce;
- - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
- - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.
Ai fini del presente articolo si ricorda che l'autoproduzione comporta l'utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.
Art. 54. Impianti fotovoltaici e solari termici
1. In riferimento a quanto disposto dal Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesaggistico regionale, e salvo quanto diversamente specificato nelle regole per le zone e sottozone e con esclusione degli edifici classificati E.V., E.R.V. e E.V.A., sono sempre ammessi, su tutto il territorio comunale:
- - impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
- - impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;
2. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dalla L.R. 11/2011 e illustrate nell'Allegato 3 della stessa legge e seguendo le prescrizioni dell'Elaborato 8b del PIT-PPR, relative alle aree con vincolo ex art. 142 comma 1 lettera C del Codice.
3. L'impianti di produzione di energia elettrica mediante "centrali fotovoltaiche", non sono ammessi su tutto il territorio comunale.
Art. 55. Impianti a biomasse
1. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
2. In attesa di tali provvedimenti operano pertanto i seguenti criteri localizzativi.
3. Gli impianti a biomasse per produzione energetica nel territorio aperto, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, con le prescrizioni relative ai limiti localizzativi di cui ai commi successivi, non sono ammessi.
4. In riferimento all'Allegato 1a del PIT-PPR "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse-Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" si applicano le prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti di produzione di energia elettrica da biomasse operanti in assetto cogenerativo ed particolare quelle di cui al capitolo 1, paragrafi 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.13, 1.14 e 1.15.
5. In riferimento all'Allegato 1a del PIT-PPR "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse-Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" si applicano le prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti di produzione di energia elettrica da biomasse non operanti in assetto cogenerativo ed particolare quelle di cui al capitolo 2, paragrafi 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.13, 2.14 e 2.15.
6. In riferimento all'Allegato 1a del PIT-PPR "Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse-Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" si applicano le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e delle opere connesse allo stesso di cui al capitolo 3.
Art. 56. Impianti eolici
1. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. In attesa di tali provvedimenti operano pertanto i seguenti criteri localizzativi.
2. Gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali non sono ammessi.
3. Gli impianti eolici domestici destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi su tutto il territorio rurale, salvo le prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per gli impianti eolici di cui all'Allegato 1b del PIT-PPR "Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici-Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" ed in particolare al capitolo 2 paragrafi 2.4, 2.7, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19.
4. Ad eccezione degli impianti di micro eolico destinati all'autoconsumo, e sempre fatti salvi i contenuti della normativa vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale, per tutti gli altri impianti eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri localizzativi.
5. In riferimento all'Allegato 1b del PIT-PPR "Norme comuni energie rinnovabili impianti di eolici- Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" si applicano le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio dell'impianti eolici e delle opere connesse allo stesso di cui al capitolo 3.
Art. 57. Criteri generali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai provvedimenti regionali e provinciali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali:
- - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
- - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
- - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;
- - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;
2. Nessun impianto per la produzione di energia elettrica può essere artificiosamente frazionato in modo tale da eludere surrettiziamente l'applicazione di normative più gravose per il proponente o aggirare specifici obblighi previsti in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Qualora il punto di connessione alla rete elettrica sia unico per più impianti caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale, l'impianto è da considerarsi nella sua interezza e per esso si applicano le procedure previste dalla soglia della potenza di picco corrispondente.
3. La realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quelli soggetti ad autorizzazione unica sia quelli soggetti a denuncia di inizio attività, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d'obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine:
- - all'esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell'impianto;
- - al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;
- - alle garanzie di smantellamento dell'impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;
- - alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d'interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell'intervento.
CAPO 2 Zone speciali
Art. 58. Aree di rispetto cimiteriale
1. In tali aree in base alla legislazione vigente non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di quelli esistenti.
2. Tali aree possono essere utilizzate per la realizzazione di verde pubblico attrezzato e sportivo e di parcheggi.
3. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza incremento di volume.
4. Le aree adiacenti ai perimetri delle strutture cimiteriali comunali per una profondità di 10 ml. sono da considerarsi aree soggette ad esproprio per pubblica utilità.
Art. 59. Area di rispetto dei depuratori
1. Per un raggio di ml 100 dagli impianti di depurazione comunali è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia. In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.
CAPO 3 Norme di tutela paesaggistica ed ambientale
Art. 60. Beni paesaggistici
1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.
2. Il P.O. recepisce i Beni paesaggistici individuati dal P.S.I.C.T., in apposito elaborato grafico. In particolare nel territorio comunale di Empoli sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:
- - Aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
- - I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142, c.1, lett. B, D.Lgs. 42/2004)
- - I fiumi, itorrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, c.1, lett. C, D.Lgs. 42/2004);
- - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, c.1, lett. G, D.Lgs. 42/2004);
3. Nelle aree ricadenti nei Beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell'Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015.
4. Negli interventi soggetti a scheda norma di cui all'Allegato B alle presenti norme, interessate dai Beni paesaggistici di cui sopra, sono state indicate le direttive e riportate le prescrizioni riportate nell'Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015
Art. 61. Aree tutelate
1.Le tutele di cui al presente capo sovrappongono le loro disposizioni alle previsioni di zona.
2.Le disposizioni di cui al presente capo sono altresì finalizzate all'adeguamento delle norme del Piano Operativo al PIT-PPR, con specifico riferimento alla disciplina dell'ambito di paesaggio, al Piano Territoriale di Coordinamento della città Metropolitana di Firenze (PTCP).
Le tutele interessano:
- a) aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica
- b) aree a protezione storico ambientale;
- c) corsi d'acqua, laghi e formazioni vegetazionali d'argine e di ripa
- d) aree boscate;
- e) aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica;
- f) geotopo di Arnovecchio;
- g) infrastrutture storiche;
- h) le riserve fluviali ed il contenimento del rischio idraulico;
- i) ambiti di tutela;
- j) aree di recupero ambientale;
- k) parco fluviale dell'Arno;
- l) aree naturali protette d'interesse locale-ANPIL;
- m) ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL;
- n) le aree sensibili di fondovalle
Art. 61.1 Aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica
1. Il Quadro Normativo Archeologico Comunale ha come obbiettivo la regolamentazione e definizione delle azioni da effettuare, da parte dell'Amministrazione Comunale (A.C.), nel momento in cui un singolo privato o un Ente interviene con opere di scavo a vari livelli sul territorio comunale in riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e Codice dei Contratti oppure si abbia richiesta di consultazione e/o utilizzo del materiale inerente la materia in oggetto, da parte dei soggetti predetti.
2. Il presente Quadro Normativo avrà come conseguenza diretta la salvaguardia di aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologico fermo restando che la tutela dei beni culturali è, a termini di legge, prerogativa delle Soprintendenze competenti. All'A.C., con gli uffici preposti, competerà, a norma di legge, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici individuati.
3. Dette aree non hanno valenza di aree tutelate per legge di cui all'art. 142 punto m) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
4. Il Quadro Normativo presente ha come oggetto d'applicazione il Territorio del Comune di Empoli e in particolar modo quelle zone individuate dalla Carta di Rischio Archeologico (e Carte di Dettaglio) unitamente alle schede delle Unità Topografiche di Rischio Archeologico (U.T.) nelle quali si descrivono aree di interesse o rischio/potenzialità archeologico; quest'ultimo strumento in mano all'amministrazione comunale ha la possibilità di avere ulteriori aggiornamenti nell'eventualità che segnalazioni future amplino il numero delle U.T.
5. Il Piano Operativo individua le seguenti tipologie di rischio archeologico e relativa modalità di tutela:
- a) Aree di alto rischio/potenzialità archeologico e aree di attenzione
- b) Aree di medio rischio/potenzialità archeologico
- c) Aree di basso rischio/potenzialità archeologico
- d) Tutela delle U.T. lineari inerenti la struttura centuriata
- e) Tutela delle U.T. lineari inerenti l'antica viabilità
Art. 61.1.1 Aree di alto rischio/potenzialità archeologico e aree di attenzione
1. Sono le aree interessate da accertata presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico, già rinvenuti sia in regolari campagne di scavo archeologico ovvero non ancora oggetto di specifiche indagini, ma motivatamente ritenuti presenti. Sono da considerarsi ad alto rischio anche le aree che si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa con un'altissima concentrazione di U.T. individuate anche non contigue (nella maggior parte dei casi sono U.T. ad alto rischio archeologico); fra queste si possono citare ad esempio le aree dei centri storici di Empoli, Monterappoli e Pontorme, Piazzano - Il Cotone, Martignana - Il Poggiale, Monteboro -Pianezzoli - Corniola e Empoli Vecchio.
2. Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di alto rischio archeologico o di attenzione devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni.
3. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.
4. Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello di informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.
5. Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.
6. Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.
Art. 61.1.2 Aree di medio rischio/potenzialità archeologico
1. Sono le aree interessate da presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico non ancora oggetto di specifiche indagini la cui probabilità di rinvenimento è da verificare alla luce dei dati acquisiti tramite la realizzazione delle schede U.T.
2. Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di medio rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.
3. Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello di informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.
4. Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.
5. Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.
Art. 61.1.3 Aree di basso rischio/potenzialità archeologico
1. Sono le aree interessate da possibile ma non sicura ovvero allo stato del rilevamento ormai assai compromessa stratificazione archeologica e non ancora oggetto di specifiche indagini la cui probabilità di rinvenimento è da verificare alla luce dei dati acquisiti tramite la realizzazione delle schede U.T.
2. Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di basso rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. 3. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.
4. Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello di informazioni più preciso e dettagliato.
5. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.
6. Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.
7. Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.
Art. 61.1.4 Tutela delle U.T. lineari inerenti la struttura centuriata
1. Sono aree estese in modo lineare aventi un margine di rispetto di circa 2 mt a partire dal limite fisico delle stesse.
2. Queste U.T. lineari seguono ed evidenziano tuttora una organizzazione centuriata del territorio.
3. Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.
4. In queste aree si dovrà mantenere le caratteristiche essenziali che individuano l'impianto storico della centuriazione (tracciati originari, antichi incroci, orientamento canalizzazioni) elementi attraverso la sua attenta valorizzazione che a, termini di legge, spetta all'ente locale.
5. Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello di informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.
6. Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.
7. Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.
Art. 61.1.5 Tutela delle U.T. lineari inerenti l'antica viabilità
1. Sono le strade di tutte le categorie e sotto categorie amministrative (e i rispettivi elementi di pertinenza) e i fossi che ancora mostrano caratteri storici leggibili di divisione e organizzazione centuriale. La finalità di conservazione e valorizzazione concerne il mantenimento della memoria del ruolo strutturante che questi manufatti hanno avuto nell'organizzazione e sviluppo del territorio.
2. Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di alto rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. 3. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.
4. La sede della viabilità storica, secondo le indicazioni della S.B.A.T., dovrà essere mantenuta il più possibile nelle caratteristiche essenziali e preservarne testimonianza nei tracciati ed incroci. Dovranno essere altresì salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (edicole votive, colonnini ecc.). Tutti gli interventi nelle aree di maggior concentrazione di testimonianze della centuriazione dovranno tenere conto degli elementi lineari centuriati storici preservandone possibilmente la memoria mantenendo coerenza di orientamento. Sarebbe preferibile mantenere la toponomastica storica e dove ormai scarsamente utilizzata rimetterla in evidenza.
5. Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello di informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.
6. Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.
7. Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.
Art. 61.2 Aree di protezione storico ambientale
1. Sono parti del territorio rurale, che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza.
2. In queste aree non sono ammessi i seguenti interventi:
- - costruzioni stabili o provvisori di qualsiasi tipo;
- - utilizzazione di terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere temporaneo;
3. Sono ammessi interventi relativi alla realizzazione di impianti tecnologici per la pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area.
4. Il patrimonio edilizio esistente all'interno di tali aree potrà essere ampliato alle condizioni previste al precedente art. 47.3.
5. Queste aree corrispondono a quelle definite all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Città Metropolitana di Firenze.
Art. 61.3 Corsi d'acqua, laghi e formazioni vegetazionali d'argine e di ripa
1. Comprendono i torrenti, rii, canali e i loro elementi costitutivi quali alvei, argini, sponde, formazioni vegetali ripariali, opere di regimazione idraulica, inoltre gli specchi d'acqua e gli stagni, nonché le aree strettamente connesse, dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Tali risorse sono considerate come fondamentale componente ambientale e paesistica del Piano Strutturale Intercomunale delle Città e territori delle due rive e come tali andranno protette e mantenute.
2. Su tali aree si applicano le seguenti disposizioni:
- a) non sono consentiti interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
- b) sono esclusi da tali prescrizioni gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo, comprese le opere di sistemazione idraulica;
- c) all'esterno del territorio urbanizzato, non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml 15 dalla riva o dal piede dell'argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
- d) all'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di ml 15 di cui sopra sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione compatibilmente con la classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente e senza incrementi di volume. Eventuali recinzioni ammesse nella fascia di ml 15 sono da realizzare solo se di tipo naturalistico;
- e) nelle aree contermini ai corsi d'acqua ai laghi alle formazioni vegetazionali e di ripa, è possibile redigere un progetto di iniziativa pubblica o privata per consentire interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, di progettazione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e degli spazi di sosta attrezzata.
3. Le formazioni arboree, costituite da alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale o naturalistico sono sottoposti a tutela.
4. Sono sottoposte a tutela, per la testimonianza storico-culturale che rappresentano, le numerose siepi di bosso, diffuse in tutto il territorio comunale, che si trovano sia all'interno, sia all'esterno dei centri abitati con funzioni di consolidamento o perimetrazione, o lungo antiche strade.
5. In tali aree sono ammesse:
- a) attività ricreative e per il tempo libero che non comportano la realizzazione di nuovi manufatti
- b) negli edifici esistenti, le destinazioni d'uso di ristoro e commercializzazione di prodotti locali, legate ad un circuito di valorizzazione agro-ambientale
- c) nuovi attraversamenti, senza riduzione della sezione idraulica, per il collegamento di tratti della viabilità storica
- d) interventi per il miglioramento delle caratteristiche dei corsi d'acqua attraverso l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica
- e) interventi volti alla realizzazione di biotopi lungo i corsi d'acqua attraverso anche risagomature o ampliamenti della sezione idraulica
- f) interventi di sostituzione nelle opere di manutenzione, per quanto possibile, con altre che rispondano a criteri d'ingegneria naturalistica.
6. Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c del D.Lgs.42/2004 e per i laghi vincolati ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera b del D.Lgs.42/2004, valgono le prescrizioni di cui all'art.7 e 8 dell'allegato 8b della Disciplina di Piano del PIT-PPR.
Art. 61.4 Aree boscate
1. Nelle aree boscate e in quelle di vegetazione di ripa le trasformazioni devono rispettare le prescrizioni che riguardano la tutela del vincolo idrogeologico previste dalla L.R. 39/2000 .Su tali è promossa l'uso collettivo della risorsa ambientale mediante la realizzazione di percorsi a carattere naturalistico ed aree attrezzate per la fruizione (arredi per la sosta, segnaletica, pannelli informativi, ecc.). Eventuali nuove strutture sono ammesse esclusivamente per opere di interesse pubblico relative alla protezione civile antincendio boschivo e salvaguardia del patrimonio boschivo.
2. Gli interventi ricadenti all'interno di tali aree tutelate dal vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato, con particolare riferimento all'art.12.3 dell'Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.
Art. 61.5 Aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica
1. Sono le aree rappresentate nelle Tav n. 2 Disciplina del territorio rurale e Tav n. 3 Disciplina del territorio urbano del POC in coerenza con lo Statuto del Territorio del P.S.I.C.T.
2. Tale aree includono le aree boschive e forestali di cui al precedente articolo, le aree vincolate per la sicurezza idraulica, aree in frangia ai corsi d'acqua e zone umide. Nell'area sono incluse anche aree a destinazione agricola che attualmente non presentano particolari vincoli, ma che in futuro saranno destinate ad interventi, sia per ridurre il rischio idraulico che per migliorare la qualità naturalistica complessiva del territorio.
3. Ai fini di favorire la ricostruzione di ecosistemi naturali e seminaturali all'interno della zona della rete ecologica:
- a) sono vietate le attività di sbancamento, di terrazzamento, ed altri movimenti di terra, ad eccezione di quelle necessarie per l'edificazione quando autorizzate in base ai criteri di cui al seguente punto b, e di quelle necessarie alla realizzazione delle seguenti opere:
- -interventi per la difesa del suolo ed in particolare gli interventi di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, da effettuarsi comunque nel rispetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 maggio 1977, n.155;
- -le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete quali opere viarie e ferroviarie e tramvie, reti di trasmissione di energia e trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze;
- -le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene o per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimento di calcestruzzo;
- -le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili;
- b) la nuova edificazione, è consentita solo quando le dimensioni e la forma delle proprietà siano tali da rendere impossibile lo sviluppo dei volumi edilizi al di fuori dell'area, salvo che nelle aree in cui è espressamente vietata in base alle presenti norme ed alla normativa nazionale e regionale.
- c) tutti gli interventi di trasformazione all'interno dell'area dovranno comunque essere realizzati in modo da minimizzare gli elementi di "artificializzazione" e di favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali.
Art. 61.6 Geotopo di Arnovecchio
1. Il paleomeandro dell'Arno in località Arnovecchio è indicato nella Carta dello Statuto del Territorio del PTCP come geotopo di potenziale interesse provinciale;
2. Il Piano Operativo definisce la disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammissibili e detta le disposizioni al fine di preservare i connotati conformativi del territorio e del paesaggio.
3. Nella zona sono prescritti:
- a) La conservazione geomorfologica e l'idrografia del paleoalveo;
- b) Il mantenimento delle trame agricole e dei tracciati storici.
4. Nella zona sono vietate:
- a) le nuove edificazioni;
- b) la costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
- c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115
5. Per le parti del Geotopo che ricadono all'interno dell'Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) di Arnovecchio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 61.12.
Art. 61.7 Infrastrutture storiche
1. Le infrastrutture viarie storiche indicate nelle Tav. n. 2 Disciplina del territorio rurale e Tav. n. 3 Disciplina del territorio urbano devono essere conservate rispettando quando indicato del P.S.I.C.T..
2. Devono comunque essere mantenute:
- - la libera percorribilità del tracciato;
- - i caratteri planoaltimetrici del tracciato;
- - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- - le opere d'arte;
- - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
- - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.
3. Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive dell'esistente.
4. Èfatto divieto di asfaltare i tracciati non asfaltati fatta salva la possibilità di intervenire, nei soli tratti di accentuata pendenza, con sistemazioni superficiali in semipenetrazione con emulsione bituminosa o pavimentazioni ecologiche analoghe.
Art. 61.8 Le riserve fluviali ed il contenimento del rischio idraulico
1. Nelle aree per il contenimento del rischio idraulico è prevista la realizzazione di casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.
2. La posizione e la dimensione delle casse dovrà essere funzionale all'eliminazione del rischio idraulico individuato dallo studio idraulico nel quale sono evidenziate le aree soggette ad esondazione per gli eventi di piena previsti con un tempo di ritorno duecentennale.
3. I nuovi argini dovranno essere progettati in modo da garantire la percorrenza delle sponde ed una efficace copertura vegetale.
4. Le aree per il contenimento del rischio idraulico sono le aree nelle quali l'utilizzazione è condizionata alla necessità di consentire l'esondazione dei corsi d'acqua senza danni alle persone ed alle cose.
5. Per le aree individuate dall'Autorità di Bacino dell'Arno, le perimetrazioni riportate nella cartografica allegata al Piano Operativo hanno carattere ricognitivo. La esatta individuazione delle zone come la relativa normativa di intervento e le misure di salvaguardia, sono contenute nel piano di bacino del fiume Arno, ai sensi della legge 183/1989.
6. Per le aree di individuazione comunale, la perimetrazione è vincolante e le relative aree sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta e al divieto di alterazione morfologica dei terreni. Il vincolo vige anche per l'installazione di manufatti stabili o precari di qualsiasi tipologia, ivi comprese le serre e i vivai.
7. Sono esclusi dal vincolo di cui sopra, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:
- a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e a perseguire miglioramento ambientale;
- b) le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti che non comportino aumenti della superficie coperta, incremento del carico urbanistico e cambio di destinazione d'uso.
Art. 61.9 Ambiti di tutela
1. Le Tav. n. 2 Disciplina del territorio rurale e Tav. n. 3 Disciplina del territorio urbano individuano gli ambiti di tutela di siti e manufatti di rilevanza ambientale e /o storico culturale.
2. Sono le aree prevalentemente inedificate in cui sistemazioni, arredi e percorsi, esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolo-paesaggio.
3. Èprescritta la conservazione dei seguenti elementi, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:
- - le opere di sistemazione del terreno quali: muri, ciglioni, terrazzi;
- - le opere di raccolta e sistemazione delle acque;
- - le sistemazioni arboree;
- - le recinzioni;
- - i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
- - i cancelli;
- - le pavimentazioni;
- - gli arredi in genere.
4. Negli ambiti di tutela è ammessa la realizzazione di recinzioni, cancelli, accessi
percorsi che dovrà garantire il mantenimento degli elementi di cui al comma precedente e conservare tecniche costruttive coerenti con il contesto.
5. Èaltresì ammessa la costruzione di piscine, a condizione che la costruzione medesima sia possibile senza alterazione degli elementi di cui al terzo comma.
Èvietata:
- a) la realizzazione di nuove costruzioni;
- b) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- c) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115
6. Èconsentita la demolizione di volumi secondari, ove non risultino soggetti a particolari discipline, e la ricostruzione degli stessi in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, a condizione che la ricostruzione non comporti alterazioni degli elementi di cui al terzo comma del presente articolo.
7. Eventuali parcheggi interrati dovranno essere realizzati senza danno per gli elementi secondari.
Art. 61.10 Aree di recupero ambientale
1. Le Tav. n. 2 Disciplina del territorio rurale e Tav. n. 3 Disciplina del territorio urbano individuano le aree di recupero ambientale.
2. Nelle aree di recupero ambientale gli interventi sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata, ferme restando, per le parti comprese nel perimetro del PRC (Piano Regionale Cave) le prescrizioni contenute nella disciplina urbanistica del PRC e finalizzate alla definizione delle modalità di attuazione dei piani di coltivazione e di ripristino ambientale e funzionale, con le seguenti finalità:
- - Area in località Monteboro: bonifica della discarica e recupero dell'area a verde pubblico e per attività del tempo libero;
- - Area in località La Farfalla: ripristino ai fini agricoli;
- - Area in località Buonriposo: ripristino ai fini agricoli;
- - Area in località Le Coltelline: ripristino ai fini agricoli;
- - Area in località Poggio ai pini: recupero e manutenzione del complesso architettonico e delle pertinenze per gli usi consentiti;
- - Area lungo il torrente Orme: riqualificazione delle parti parafluviali, percorsi pedonali;
- - Laghi in località Arnovecchio: recupero ambientale nel contesto del parco fluviale.
Art. 61.11 Parco fluviale dell'Arno - F5
1. Le aree circostanti il fiume Arno sono individuate in cartografia come Parco fluviale dell'Arno.
2. Tali aree sono destinate al tempo libero ed alla ricreazione.
3. Fatte salve le prescrizioni di natura idraulica, i progetti per la valorizzazione delle aree dovranno assicurare la conservazione delle sistemazioni del suolo ed in particolare delle canalizzazioni, degli argini, nonché dell'assetto delle vegetazioni ripariali.
4. Nelle aree del parco non è ammessa la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare.
5. Fino alla istituzione del Parco fluviale dell'Arno trova applicazione quanto contenuto al successivo art. 61.13 con particolare riferimento alle discipline di salvaguardia.
Art. 61.12 Aree naturali protette di interesse locale (ANPIL)
1. L'ANPIL di Arnovecchio è caratterizzato da elementi geomorfologici e da sistemazioni del terreno, da sottoporre ad azioni di conservazione, restauro o ripristino e nei quali sia preordinata una frequentazione finalizzata al tempo libero, alla motorietà all'aria aperta, alla visibilità delle emergenze storico ambientali, anche in rapporto alla presenza di ecosistemi della flora e della fauna.
2. Le attività, le sistemazioni ed i criteri di conservazione delle risorse presenti devono essere definiti da un progetto unitario di iniziativa pubblica.
3. Nell'area non è ammessa:
- a) la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare;
- b) la costruzione di elettrodotti in linea aerea;
- c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115
4. Èvietata la nuova edificazione e la realizzazione di nuova viabilità con esclusione di quella di interesse comunale e sovra comunale.
Gli edifici e gli altri manufatti esistenti sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
- - abitazioni rurali;
- - annessi rustici;
- - allevamenti
- - commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
- - attività ricettive limitate all'agriturismo.
5. In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:
- - Manutenzione straordinaria (MS);
- - Restauro e risanamento conservativo (RC);
- - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RE);
6. Èconsentita la realizzazione di manufatti precari di cui agli Artt. 45.2.1 e 45.2.2 nel rispetto
delle prescrizioni in essi contenute.
7. In caso di mutamento di destinazione d'uso le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
- - residenziale;
- - artigianale per la produzione di beni artistici;
- - artigianale di servizio;
- - commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
- - direzionale;
- - turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
8. Interventi che comportano una variazione dell'area di sedime maggiore prevista per le diverse zone potranno essere valutati nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti.
9. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la perdita delle destinazioni d'uso agricole degli edifici rurali, potranno riguardare solo gli immobili già asserviti dalla viabilità pubblica, di uso pubblico o privata esistente, senza necessità di ulteriori adeguamenti funzionali.
10. Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:
- - delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
- - degli assetti poderali;
- - dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale la cui manutenzione dovrà avvenire senza l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti;
- - delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
- - degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;
- - delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, in pietra o mattoni faccia a vista da ripristinarsi utilizzando gli stessi materiali.
11. La realizzazione di nuove recinzioni potrà avvenire con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
- - con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, e m.1,80 limitatamente ai montanti del cancello d'ingresso, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici e/o dei coltivi di pregio, ove sussistono tracce della loro esistenza;
- - con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno o in ferro con fondazione isolata su ogni singolo palo e completamente interrata, mascherate sul lato interno con siepi di essenze arbustive, perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione, di coltivi di pregio e di allevamenti zootecnici.
In particolare:
- - vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche analoghe alle preesistenti;
- - è vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
- - le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici.
- - la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la valenza paesistica.
Art. 61.13 Ambiti di reperimento per l'istituzione di Parchi, Riserve e ANPIL
1. Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale gli ambiti del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta; essi sono in particolare caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Città Metropolitana di Firenze. Le tutele da applicare per le suddette aree sono le seguenti:
- - la dotazione boschiva e le formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi indicate dal Piano Operativo;
- - i complessi di edifici e manufatti rurali;
- - i percorsi storici, la viabilità vicinale e poderale e dei sentieri;
- - le forme gli aspetti agrari tradizionali, di coltivazione tradizionali;
- - gli elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il paesaggio agrario quali sistemazioni idrauliche, terrazzamenti, muri a secco, ciglionamenti, ecc.;
- - le condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed ecologica.
2. Fino all'istituzione di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale, in tali ambiti sono consentiti, ove non risultino soggetti a particolari discipline, tutti gli interventi previsti dal Piano Operativo per le singole zone territoriali omogenee, a condizione che tali interventi favoriscano (o risultino comunque compatibili con) l'istituzione di parchi, riserve naturali ed ANPIL.
3. In particolare gli interventi modificatori dell'aspetto esteriore dei luoghi e dei manufatti dovranno risultare compatibili rispetto ai valori identitari locali e congrui con i criteri di gestione dell'immobile e dell'area, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi e della capacità di assorbimento visuale nonché la dimensione di intervento in rapporto alla consistenza dell'esistente.
4. Gli edifici e/o manufatti legittimi, che alla data di adozione del Piano Operativo risultino avere una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito o destinazioni d'uso non consentite per la zona territoriale omogenea di appartenenza, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale.
5. Le attività produttive (artigianali ed industriali) esistenti ricadenti nell'ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette d'interesse locale, non possono essere ampliate e devono essere rese compatibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico con il contesto di riferimento.
6. Altre attività non ammissibili o incongrue comunque legittimate alla data di entrata in vigore del Piano Operativo, possono permanere fino alla cessazione d'attività.
7. I servizi e le attrezzature di interesse comunale sovra comunale ricadenti in questo ambito devono garantire la massima integrazione paesaggistica e ambientale, ed il contenimento degli impatti visuali.
8. Le infrastrutture di comunicazione lineare (viabilità, ferrovia, ecc.) sono ammesse a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.
9. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili, negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree e la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare, a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.
10. Resta comunque vietata la realizzazione, in questi ambiti, di:
- - gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- - gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115
Art. 61.14 Le Aree sensibili di fondovalle
1. Le aree sensibili di fondovalle sono aree di estensione e rilevanza sovracomunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio comunale provinciale. In queste aree si applicano le disposizioni di cui all'art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Città Metropolitana di Firenze.
CAPO 4 Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
Art. 62. Norme Generali per la sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
1. Il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale delle Città e territori delle due rive e del PIT-PPR, tutela l'integrità fisica e l'identità paesaggistico ambientale del territorio e, sulla base delle attività svolte per la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i criteri ed i limiti per un uso consapevole e sostenibile delle risorse ambientali.
2. Gli interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia sono ammessi solo se nelle aree ove siano già presenti o vengano contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro i rischi di esondazione e da frana, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e di adeguate infrastrutture per la mobilità veicolare e per la sosta.
3. Nel successivo art. 63 il Piano Operativo stabilisce criteri da seguire e norme da rispettare, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione: alle modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della permeabilità dei suoli; all'approvvigionamento ed al risparmio idrico; alla depurazione; alle emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale; alla limitazione dell'inquinamento acustico; al potenziamento della raccolta differenziata; al risparmio energetico. Il Regolamento Edilizio può ampliare e precisare le norme sopraindicate, dettagliando i parametri e le condizioni da rispettare nei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica ai fini della tutela delle risorse ambientali e del risparmio idrico ed energetico.
4. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni della Valutazione Ambientale Strategica. In particolare i piani attuativi dovranno dare dettagliatamente dare conto del rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche schede di valutazione di ciascuna area contenute nel Rapporto Ambientale.
Art. 63. Norme specifiche di tutela per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
1. Per tutti gli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia conservativa si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in un'apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi di costruzione per interventi di nuova costruzione.
Art. 63.1 Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali
1. Èvietata l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.
2. Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:
- - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
- - contenere gli scavi e i riporti;
- - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
- - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
- - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche di ingegneria naturalistica.
3. Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico.
4. In caso di ampliamento o creazione di nuove aree verdi, pubbliche e private, deve essere privilegiata la messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici.
Art. 63.2 Approvigionamento e risparmio idrico
1. In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle seguenti tipologie di trasformazione:
- a) trasformazioni ed utilizzi che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1000 mc/anno;
- b) trasformazioni ed utilizzi che possono comportare impatti ambientali rilevanti sul sistema acqua.
2. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l'intervento è tenuto a:
- a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall'intervento;
- b) valutare l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune e sulla qualità delle acque;
- c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
- - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
- - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
- - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
- d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. In ogni caso i nuovi fabbisogni non devono essere soddisfatti con approvvigionamenti diretti dai corpi sotterranei a deficit di bilancio.
- a) prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
- c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile(quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
- d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.
3. Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:
Art. 63.3 Depurazione
1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è tenuto a:
- a) valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall'intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- b) dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.
2. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- a) Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
- b) In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.
Art. 63.4 Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale
1. Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni:
- a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
- b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.
2. Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.
3. Per tutti i casi non rientranti nelle categorie precedenti il Comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano adottare alcune delle disposizioni indicate.
4. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l'intervento è tenuto a valutare:
- a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
- b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
- - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
- - all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
- - all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto d'intervento o trasformazione;
- - al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.
- c) la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.
Art. 63.5 Inquinamento acustico
1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare la vigente normativa di settore, in particolare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall'Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell'esistente.
Art. 63.6 Risparmio energetico
1. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.
2. Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d'uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:
- a) l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
- b) l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
- c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
- d) l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
- e) la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso laprogettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.
3. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l'intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
- b) cogenerazione;
- c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se
disponibili;
- d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- e) "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza. Energy ascading);
- f) pompe di calore;
- g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.
4. Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:
- - i consumi energetici previsti per l'utilizzo dell'immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l'energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all'attività lavorativa;
- - il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
- - i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
- - le emissioni in atmosfera.
5. Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:
- - l'orientamento dell'immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell'irraggiamento solare;
- - i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
- - l'ombreggiamento esterno dell'edificio con specie spoglianti che consentano l'irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell'effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc;
- - il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
- - i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
- - la predisposizione di opere per l'installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
- - altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.
Art. 64. Strategie e azioni ecosistemiche - Nature Based Solutions
1. Il Piano Operativo persegue gli obiettivi strategici riportati all'interno del "Patto per il Verde" approvato dal C.C. con Delib.n.49/2023.
2. Le Nature Based Solutions (NBS) sono interventi verdi localizzati in ambito urbano e periurbano con lo scopo di far fronte alle sfide poste dai cambiamenti degli ecosistemi, con soluzioni versatili ispirate alla natura.
3. Il Piano Operativo recepisce specifiche categorie di intervento per l'applicazione delle NBS in relazione ai seguenti ambiti:
- - 1.1 Messa a dimora di alberi
- esempio 1: box di bioritenzione
- esempio 2: alberature stradali
- esempio 3: foresta urbana
- - 1.2 Arredo urbano integrato al verde
- esempio 1: parklets
- - 1.3 Regimentazione e depurazione delle acque
- esempio 1: aree di bioritenzione e rain gardens
- - 1.4 Interventi di demineralizzazione
- esempio 1: pavimentazioni permeabili inverdite
- esempio 2: riapertura corsi d'acqua tombati
- - 1.5 interventi sul suolo
- esempio 1: fitorimedio
- - 1.6 Interventi sugli elementi orizzontali degli edifici
- Esempio 1: Tetto verde estensivo ed intensivo
- Esempio 2: Tetto verde "smart"
- Esempio 3: Tetto verde per impollinatori
- - 1.7 Interventi di verde verticale su edificio
- Esempio 1: Facciate verdi e living walls
- Esempio 2: Verde sul balcone
- - 1.8 Interventi di verde free standing
- Esempio 1: Barriere verdi e barriere verdi filtranti
- Esempio 2: Percorso pergolato
- - 1.9 Sistemi di coltivazione a scala dell'edificio
- Esempio 1: Vertical farming
- Esempio 2: Rooftop farms
- Esempio 3: Rooftop greenhouse
- - 1.10 Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana
- Esempio 1: Floating farms
- Esempio 2: Orti Sociali
- Esempio 3: Food forest
- Esempio 4: Agroforestazione
- - 1.11 Verde indoor
- Esempio 1: Filtrazione botanica
- - 1.12 Trattamento rifiuti organici
- Esempio 1: Compostaggio comunitario
4. Gli ambiti di intervento sopra indicati trovano specifico riferimento all'interno delle Schede Norma di cui all'Allegato B, diversificando i vari ambiti di intervento in base al contesto urbano, alla tipologia architettonica e di eventuale trasformazione del tessuto.
5. Per i tessuti B e D l'utilizzo delle NBS è sempre consentito e incentivato dal presente Piano Operativo.
6. Per i nuovi interventi pubblici riferiti a parcheggi e verdi attrezzati, l'utilizzo delle NBS è da considerarsi obbligatorio, mentre per tutte le altre attrezzature di carattere pubblico il ricorso alle NBS è da ritenersi indicativo e sarà valutato in relazione alle peculiarità del progetto da realizzare secondo la disciplina del Regolamento indicato al comma successivo.
7. Per gli interventi di carattere privato, l'utilizzo delle NBS è incentivato dal Piano Operativo, con specifiche riduzioni dei contributi concessori che saranno regolati e definiti nel dettaglio da apposito Regolamento di Attuazione per l'applicazione degli NBS. Tale Regolamento potrà costituire parte integrante del Regolamento Edilizio.
8. Le opere a standard, riferite a verdi attrezzati e/o parcheggi pubblici, da realizzare e cedere all'Amministrazione Comunale da parte dei soggetti attuatori nell'ambito della realizzazione di PUC, PUA_AT e PUA_RQ dovranno obbligatoriamente essere effettuate con l'applicazione delle NBS.
9. Nelle more di applicazione del Regolamento di Attuazione delle NBS, gli interventi di cui al comma 7, la disciplina delle NBS è da ritenersi indicativa e non obbligatoria.
Titolo VII: DISCIPLINA DI TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. NORME FINALI
CAPO 1 Tutela dell'integrità fisica del territorio
Art. 65. Disposizioni generali
1. Generalità. La disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio di cui al presente "capo" recepisce le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale, piani di settore e atti di governo del territorio dei diversi soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica, idrogeologica e sismica di cui a:
- - DPGR 5/R del 30.01.2020;
- - LR 41/2018;
- - DLgs 152/ 2006 con particolare riferimento alla Parte III;
- - Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Firenze di cui alla DCP n. 1/2013 di approvazione della variante di adeguamento del PTCP ai sensi dell'art.17 della LR 1/2005;
- - Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA);
- - Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI);
- - Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno;,
- - Progetto di Piano del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto PAI Dissesti geomorfologici);
- - Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA);
- - Piano di Bacino stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI);
coordinandole con la normativa urbanistico-edilizia e con le previsioni di cui al presente Piano Operativo.
Ogni modifica e/o integrazione alle disposizioni di cui agli strumenti sovraordinati approvati successivamente all'entrata in vigore del presente Piano Operativo è oggetto di adeguamento approvato con presa d'atto del Consiglio Comunale.
2. Elaborati di riferimento. Costituiscono oggetto dell'articolazione normativa del presente Piano Operativo:
- -la disciplina finalizzata alla salvaguardia e riduzione del rischio idraulico;
- -le disposizioni finalizzate alla protezione e al governo della risorsa idrica;
- -le disposizioni finalizzate alla salvaguardia e riduzione dei rischi geologico e sismico;
- -i criteri di fattibilità da applicarsi agli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nelle aree con pericolosità geologica, idraulica e sismica contenuti nelle singole schede norma sulla base degli interventi ivi previsti.
Tali disposizioni, criteri, condizioni e prescrizioni di fattibilità assumono valenza prescrittiva.
La presente disciplina si pone in diretta relazione con i contenuti dei seguenti elaborati del "Piano Strutturale Intercomunale delle due rive", allestiti per il territorio comunale di Empoli:
- -Elaborato QG.03 - Carta idrogeologica e vulnerabilità degli acquiferi;
- -Elaborato QG.04 - Carta della pericolosità geologica;
- -Elaborato QG.05 - Carta della pericolosità sismica;
- -Elaborato QI.06d_Magnitudo idraulica
- -Elaborato QI.07d_Proposta di modifica al Piano Gestione Rischio Alluvioni
3. Criteri di fattibilità. I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, al rischio di alluvioni, a problematiche connesse alla risorsa idrica e in relazione agli aspetti geologici per gli interventi previsti/ammessi dal Piano Operativo sono definiti sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 e sulla scorta dei principi generali fissati dal Piano Strutturale Intercomunale, quali indirizzi per il Piano Operativo.
I criteri di fattibilità individuati in relazione agli aspetti sismici sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale Intercomunale, oltre ad essere conformi alle prescrizioni generali della normativa regionale vigente (ex paragrafo C.3 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020), recepiscono anche gli studi di microzonazione sismica effettuati per il Comune di Empoli (Microzonazione Sismica MS1 e MS2 facenti parte del quadro conoscitivo), che hanno portato alla mappatura del fattore di amplificazione sismica su vasti areali che includono tutti i territori urbanizzati del territorio comunale.
I criteri di fattibilità degli interventi ordinari relativi al patrimonio edilizio esistente ed alle infrastrutture, che non siano soggetti nelle "schede norma" del presente Piano Operativo devono essere definiti, secondo quanto disposto al paragrafo 3 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale Intercomunale. Per edifici e/o infrastrutture ricadenti in classi di pericolosità differenti deve essere considerata quella più elevata o comunque quella finalizzata ad ottenere condizioni maggiormente cautelative.
I criteri di fattibilità degli interventi disciplinati con apposita scheda norma (ID, PUC, PUA-RQ ,PUA -AT*e OP) sono individuati nella specifica sezione criteri di fattibilità e prescrizioni; per gli interventi che trovano attuazione attraverso l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi, i criteri di fattibilità devono essere ridefiniti sulla base di considerazioni di maggior dettaglio derivanti da appositi studi (campagne di indagini geognostiche mirate alla situazione sitospecifica, modellazioni idrauliche sulla base della proposta progettuale, ecc). Le limitazioni ed i condizionamenti individuati si aggiungono e non sostituiscono quelli determinati dalle normative di settore.
Su tutto il territorio comunale sono consentiti interventi funzionali a ridurre il livello di pericolosità territoriale e conseguentemente a rivalutare la possibilità di modifica dei criteri di fattibilità a condizione che non aggravino la condizione delle aree contermini o comunque correlate.
Le prescrizioni relative ai criteri di fattibilità sono state schematizzate e distinte in relazione ai 4 aspetti: geologico, idraulico, sismico e tutela della risorsa idrica sotterranea (idrogeologico).
Art. 66. Criteri di fattibilità e prescrizioni in relazione agli aspetti geologici
1. Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020.
2. Classificazione delle aree a pericolosità geologica. L'attribuzione delle classi di pericolosità geologica è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione geologica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale.
Per la comprensione della nomenclatura in uso per la classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica nei disposti normativi in vigenza di cui al:
- -PAI del bacino dell'Arno (AdB);
- -PAI del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale Distrettuale (ADAS);
- -DPGR 53/R/2011;
- -DPGR 5/R/2020;
si riporta il seguente schema esemplificativo con la sintetica identificazione della classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione, susseguitasi nel tempo, nei vari disposti normativi.
| Abaco della Pericolosità geologica/geomorfologica nell'evoluzione della normativa sovracomunale | |||
|---|---|---|---|
| DPGR. n. 53/R/2011 | DPGR. n. 53/R/2020 | PAI AdB Arno | PAI Distretto App Sett. |
| G.4 (molto elevata) | G.3 (elevata) | G.2 (media) | G.1 (bassa) |
| G.4 (molto elevata) | G.3 (elevata) | G.2 (media) | G.1 (bassa) |
| P.F.4 (molto elevata) | P.F.3 (elevata) | P.F.2 (media) | P.F.1 (bassa) |
| P.4 (molto elevata) | P.3 (elevata) | P.2 (media) | P.1 (bassa) |
Nella tavola QG.04 Pericolosità geologica del Piano Strutturale Intercomunale sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle classi di pericolosità geologica ai sensi del DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1.
3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica molto elevata G4. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.1 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 10 delle Norme di Piano ed Allegati del PAI Arno).
3.1 Fattibilità G4 | nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione, (ai sensi della LR 41/2018) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio tesi alla riduzione della pericolosità e/o alla mitigazione del rischio. Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 e devono esser tali da:
- -non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- -non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- -consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza deve essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e l'Ente sovracomunale preposto al controllo.
Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.
3.2 Fattibilità G4 | altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:
- -la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- -gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- -la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso;
- -l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell'importanza dell'opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle caratteristiche del dissesto attivo in atto.
3.3 Fattibilità G4 | scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell'area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.
4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A al DPGR n. 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 11 delle Norme di Piano ed Allegati del PAI Arno).
4.1 Fattibilità G3 | nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione (ai sensi del DPGR 5r/2020) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità da effettuarsi in fase di pianificazione attuativa o di presentazione di progetto per il rilascio del titolo abilitativo.
Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio, tesi a verificare l'efficacia degli stessi.
Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e devono essere tali da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza dovrà essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e l'Ente sovracomunale preposto al controllo.
Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi.
4.2 Fattibilità G3 | altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:
- - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- - la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso;
- - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell'importanza dell'opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle sue caratteristiche in relazione alla possibilità potenziale di esposizione al dissesto.
4.3 Fattibilità G3 | scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico, da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell'area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.
5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica media G2. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.3 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 12 delle Norme di Piano ed Allegati del PAI Arno).
5.1 Fattibilità G2 | nuova costruzione/altri interventi. La fattibilità degli interventi di:
- - nuova costruzione (ai sensi della LR 41/2018);
- - nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- - incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- - ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso;
- - ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è condizionata alle risultanze di specifiche indagini geologiche, geognostiche e geofisiche da eseguirsi in fase progettuale, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.
6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica bassa G1. Sono consentite tutte le tipologie di intervento, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
7. Direttive per la formazione dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e dei progetti edilizi. I Piani Attuativi, i Piani di Recupero, i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), le attività permesse nelle aree di trasformazione e i progetti edilizi, fatte salve ulteriori ed eventuali prescrizioni contenute nel Piano Strutturale o nel presente Piano Operativo, devono essere corredati di elaborati geologici, geotecnici e di modellazione sismica contenenti gli esiti di apposite indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da effettuare in relazione alla classe di indagine in cui ricade l'intervento, così come definita al paragrafo 3 dell' Allegato 1 - art. 5 DPGR 1/R/2022.
Art. 67. Fattibilità per fattori idraulici
1. Criteri di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.3 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020 Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni.

1.1 Modellazione idraulica. I livelli idraulici di riferimento per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico e per l'eventuale programmazione/progettazione degli interventi di messa in sicurezza e/o riduzione del rischio, devono essere acquisiti dagli studi di modellazione quantitativa del Piano Strutturale (tavole con indicazione di pericolosità idraulica, battenti di esondazione per Tr 200 anni e magnitudo idraulica del reticolo oggetto di studio), fatto salvo eventuali studi successivi sostitutivi o integrativi, rispetto a quelli impiegati per le elaborazioni del Piano Strutturale Intercomunale e del presente Piano Operativo.
1.2 Tempo di ritorno TR 200. Ogni considerazione in relazione a valutazioni di rischio ed azioni finalizzate alla sua riduzione per la definizione dei criteri di fattibilità, deve avere a riferimento l'evento ricorrente con tempo di ritorno Tr 200 anni.
1.3 Gestione-riduzione del rischio/messa in sicurezza. Nella progettazione degli interventi di gestione del rischio, riduzione del rischio idraulico e/o messa in sicurezza si deve operare tenendo conto di un franco di sicurezza rispetto al livello idraulico di riferimento (battente di piena per Tr 200 anni) come sotto definito:
- a) per le aree esondabili da parte di corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale 0,50 ml;
- b) per le aree esondabili da parte dei corsi d'acqua afferenti al reticolo secondario 0,30 ml.
In caso di area interessata sia da eventi derivanti dal reticolo principale, sia da reticolo secondario, la sicurezza idraulica deve essere garantita rispetto al più gravoso dei due scenari.
2. Classificazione delle aree a pericolosità da alluvioni. L'attribuzione delle classi di pericolosità da alluvioni è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione idrologico idraulica (quadro conoscitivo del PSI) redatta a compendio degli studi di modellazione quantitativa a supporto del Piano Strutturale Intercomunale e conforme ai criteri del comma C.2 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020.
2.1 Magnitudo idraulica. La LR 41/2018 introduce, all'art. 2, lettere h1, h2 e h3, il concetto di magnitudo idraulica, quale criterio per la valutazione di fattibilità idraulica in relazione alla gestione del rischio idraulico.
Si riporta il seguente schema esemplificativo relativo alla determinazione della classe di magnitudo idraulica in funzione della determinazione o meno della velocità della corrente.
Schema delle magnitudo
3. Fattibilità in aree classificate a rischio di alluvioni. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla LR 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
4. Direttive per la formazione dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e dei progetti edilizi. I Piani Attuativi, i Progetti Unitari Convenzionati e i progetti edilizi ricadenti in aree a pericolosità per alluvioni frequenti e/o poco frequenti, devono essere corredati da specifici elaborati grafici riportanti planimetrie e sezioni/prospetti in cui sia individuata, in termini di quote assolute (m slm), la quota di sicurezza idraulica per Tr 200 anni, oltre il relativo franco di sicurezza definito al punto 1.3 del presente articolo.
4.1 Modellazione idrologico idraulica. Il livello idraulico di riferimento ai fini della progettazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica deve essere derivato dagli studi di modellazione idrologico idraulica del quadro conoscitivo del PSI, salvo eventuali studi successivi sostitutivi o integrativi validati/approvati dalle autorità competenti.
4.2 Sistema di riferimento altimetrico (LIDAR). Le proposte progettuali e/o le modellazioni idrauliche quantitative devono basarsi su dati altimetrici, individuati su cartografia Lidar, se disponibile, o su dati altimetrici derivanti da specifici rilievi di cui ne sia verificata la coerenza plano altimetrica con la cartografia Lidar.
5. Misure per la riduzione della pericolosità da alluvioni e della magnitudo. La gestione del rischio di alluvioni, finalizzata al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 e il non aggravio delle condizioni di rischio idraulico, devono essere assicurati mediante la realizzazione delle opere di cui all'art. 8 della LR41/2018. Per maggiori dettagli tecnici sulla definizione delle condizioni di rischio R2 (in particolare per parcheggi e infrastrutture di viabilità) si rimanda alla relazione di fattibilità geologica ed idraulica a supporto del PO.
6. Fattibilità in aree non soggette a rischio alluvioni. Ad interventi e previsioni esterni ad aree classificate a pericolosità da alluvioni non si attribuiscono prescrizioni specifiche per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo opportune indicazioni di misure per il riordino o ripristino del drenaggio superficiale.
7. Fattibilità in aree presidiate da sistemi arginali non soggette a rischio alluvioni. Nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, così come definite nella LR 41/2018 art. 2 lettera s, per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale. A tal fine il Comune, entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.
8. Fattibilità nelle aree di contesto fluviale. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10m dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, come definito ed individuato dalla LR 79/2012, la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla LR 41/2018 e nel rispetto della normativa di settore sovraordinata R.D. n. 523/1904.
9. Fattibilità nelle aree di fondovalle fluviale. Nelle aree di fondovalle fluviale evidenziate nelle tavole di Piano Strutturale la fattibilità degli interventi è condizionata alla realizzazione di studi idraulici con grado di dettaglio adeguato ad individuare il livello di rischio dell'area di intervento.
10. Invarianza idraulica a seguito dell'impermeabilizzazione dei suoli. Nell'ambito di Piani Attuativi, Piani di Recupero, Progetti Unitari Convenzionati e progetti di opere pubbliche comportanti incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà essere prevista la realizzazione di idonei sistemi di laminazione, volti a garantire l'invarianza tra le condizioni ante e post opera della portata massima in uscita dalla rete di raccolta acque meteoriche dell'area di trasformazione, sia essa costituita da sistemi di fognatura o dal reticolo idrografico minore. L'invarianza idraulica dovrà essere valutata con riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno ventennale (Tr20) e durate di pioggia rappresentative per il caso in esame, facendo riferimento a metodi di calcolo di adeguato grado di dettaglio per la tipologia di intervento in esame. Il presente comma trova applicazione anche ad interventi di edilizia diretta comportanti un ampliamento della superficie impermeabile superiore del 30% rispetto allo stato ante intervento.
Art. 68. Fattibilità per fattori sismici
1. Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.6 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020.
2. Classificazione delle aree a pericolosità sismica. L'attribuzione delle classi di pericolosità sismica è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione geologica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale e comunque conforme ai criteri dettagliati al paragrafo C.3 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020. Tali valutazioni sono basate sugli esiti degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 e 2 elaborati a compendio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi del DPGR 5/R/2020.
3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica molto elevata S4. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S4, già in fase di Piano Operativo debbono essere svolti studi di approfondimento di cui al dettaglio dei paragrafi 3.2.1 e 3.6.1 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020. Tutti gli interventi consentiti, indipendentemente dalla modalità attuativa (PA, PUC, ecc), devono essere sottoposti a studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento, per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica.
3.1 Classe S4 | nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione in aree di instabilità di versante attive, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo quanto stabilito ai paragrafi 3.6.2 e 3.2.1, lettera a dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 come specificato al comma 3.1 dell'art. 66 della presente disciplina.
3.2 Classe S4 | altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:
- -la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- -gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- -l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; relativamente alle aree di instabilità di versante attive è subordinata all'applicazione dei criteri definiti al paragrafo 3.2.1 lettera b dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 come dettagliato anche al comma 3.2 dell'art. 66 delle presenti norme, nonché all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4);
- -la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).
3.3 Interventi non condizionati. Sono consentiti, in aree classificate a pericolosità sismica S4, senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica elevata S3, S3f e Slq. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S3 si applicano i criteri di fattibilità previsti ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020.
4.1 Classe S3f | nuova costruzione. Nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità S3f), la fattibilità degli interventi di nuova costruzione è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020. Come dettagliato al comma 4.1 dell'art. 66 delle presenti norme, gli studi sono commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento (DPGR 1/R/2022) e finalizzati all'elaborazione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto anche dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'ODPCM 3907/2010.
4.2 Classe S3f | altri interventi. Nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità S3f), la fattibilità degli interventi che interessano:
- - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020. Come dettagliato al comma 4.2 dell'art. 66 delle presenti norme, gli studi sono commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento (DPGR1/R/2022) e finalizzati, alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, tenendo conto anche dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
4.3 Classe S3lq. Nelle aree con presenza di terreni potenzialmente suscettibili di liquefazione dinamica (classe di pericolosità S3lq), per i quali sulla base delle informazioni disponibili non sia stato possibile escludere a priori il rischio di liquefazione negli studi MS2, si prescrive che vengano realizzate indagini geognostiche sitospecifiche e svolte considerazioni geotecniche per il calcolo del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni in maniera sistematica sull'estensione di verticali da accertare mediante indagini puntuali per la definizione dell'Indice del potenziale di liquefazione, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione" - LIQ, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'o.d.p.c.m.3907/2010, atte e finalizzate alla verifica e al confronto con i valori dell'indice di liquefazione derivati e desunti dagli studi di Microzonazione Sismica di livello 2.
Si prescrive che le verifiche di cui sopra debbano essere realizzate con approfondimenti geognostici in sito da eseguirsi già in fase di Piano Attuativo e/o PUC (ove questi strumenti di attuazione sia previsti) o, in loro assenza, in fase di progettazione edilizia (rilascio di permesso di costruire, approvazione di opera pubblica, SCIA, ecc), ad integrazione di quanto codificato a livello di NTC_2018 e DPGR n. 1/R/2022, secondo le casistiche di cui al dettaglio che segue:
- - per edifici in classe di indagine 2 (DPGR n. 1/R/2022) mediante prove CPT;
- - per edifici in classe di indagine 3 e 4 (DPGR n. 1/R/2022) mediante prove CPTU e valutazioni qualitative basate su fusi granulometrici.
In caso siano verificate condizioni di rispetto e/o suscettibilità per liquefazione per IL > 5 , la fattibilità è subordinata alla realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica dei terreni in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione", da progettare in funzione degli esiti delle verifiche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell'Indice del potenziale di liquefazione).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali interventi potranno essere realizzati mediante: incremento della densità del terreno, compattazione del terreno, riduzione del grado di saturazione con incremento delle pressioni efficaci, dissipazione e controllo della pressione dell'acqua, controllo della deformazione al taglio e dell'eccesso di pressione neutra.
4.4 Classe S3 | campagna di indagini. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità S3), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 o 3 (FA_0.1-0.5>1,4), la fattibilità di ogni intervento è subordinata agli esiti di una specifica campagna di indagini geofisiche individuate sulla base del contesto sismostratigrafico dell'area derivante dagli studi di microzonazione sismica (profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro, MASW, ESAC, HVSR, ecc) e geognostiche (sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo, CPT, DPSH, ecc), che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l'entità del/dei contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordo valle è necessaria, in aggiunta, una ricostruzione bidimensionale con prove geofisiche di superficie del tipo sismica a rifrazione o a riflessione.
4.5 Classe S3, S3f, S3lq | patrimonio edilizio esistente. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in aree classificate in classe di pericolosità sismica S3, S3f e S3lq) è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4. Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici.
4.6 Classe S3 / Edifici strategici, rilevanti e adibiti a pernottamento. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità S3 per amplificazione stratigrafica), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 (FA_0.1-0.5>1,4), la fattibilità degli interventi di realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti nelle classe d'indagine 3 o 4 (DPGR 1/R/2022) e di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4 (DPGR 1/R/2022), come definite dal regolamento di attuazione di cui al DPGR 1/R/2022 è subordinata alla valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, mediante specifiche analisi di risposta sismica locale RSL (in conformità NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione.
4.7 Interventi senza condizioni. Sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica media S2. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S2 si applicano le condizioni di fattibilità previste al paragrafo 3.6.5 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020.
6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica bassa S1. Sono consentite tutte le tipologie di intervento senza specifici condizionamenti per la fase attuativa e/o per la valida formazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
Art. 69. Fattibilità connessa alla risorsa idrica
1. Criteri generali di fattibilità connessi a problematiche inerenti la risorsa idrica.
I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.5 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020, fatto salvo i disposti normativi dei piani sovraordinati.
1.1 Uso della risorsa idrica. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:
- - allacciamento alla rete acquedottistica;
- - preventiva valutazione del fabbisogno idrico e contestuale verifica di sostenibilità con l'Ente Gestore per gli interventi relativi alle aree di trasformazione che prevedano nuovi insediamenti;
- - riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione dei tratti della rete, sulla base delle valutazioni dell'Ente Gestore nell'ambito dell'attuazione dei propri interventi;
- - massimizzazione della raccolta e reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- - utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;
- - recupero e riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.
1.2 Qualità della risorsa. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:
- - l'allacciamento all'infrastruttura fognaria; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;
- - l'adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o nel caso sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo.
1.3 Opere interrate e interferenze con la falda. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sulle acque sotterranee connesso a nuove infrastrutture interrate, volumi interrati nonché opere strutturali e fondali che possano interagire con la falda, deve essere predisposto un appropriato quadro conoscitivo sitospecifico ante operam, che contenga i dati idrogeologici di sito necessari per delineare la fattibilità dell'intervento sia in fase di corso d'opera che in fase post opera, ed individuare eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell'ottica della tutela della risorsa stessa. Per gli interventi che prevedono strutture sotterranee di rilevanza (parcheggi interrati multi piano, opere di presidio di fronti di scavo, sottopassi e tunnel ecc.) in fase di progettazione devono essere condotti specifici studi per la valutazione dell'impatto sulla dinamica di flusso della falda e sulla qualità della risorsa. Tali studi si basano su una modellazione idrogeologica delle modifiche correlabili alle configurazioni dello stato ante operam, durante la gestione di cantiere, post operam, con riferimento inoltre a modifiche dei livelli di falda anche in relazione alle opere circostanti.
Al verificarsi di situazioni di significative interferenze idrogeologiche si deve provvedere alla progettazione di specifiche opere di mitigazione.
2. Criteri di fattibilità in relazione alle condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. La classificazione di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea è definita nella "Carta idrogeologica" (tavv. QG.03) facente parte del quadro conoscitivo del PSI.
2.1 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità "molto elevata" e "medio elevata". In tali aree si prescrive, in linea di massima, che venga escluso l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U.; stoccaggio di sostanze inquinanti; depuratori; depositi di carburanti; pozzi neri a dispersione; spandimenti di liquami, etc.
Le fognature dovranno essere realizzate con manufatti e/o sistemi che garantiscano dallo sversamento di reflui nel terreno. Sono fatti salvi aggiornamenti legislativi in merito.
Deroghe a queste linee di indirizzo potranno essere realizzate nel caso che:
- - si dimostri la necessita, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare comunque la previsione in tali zone;
- - vengano eseguite specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde; a tal fine dovranno essere misurate le permeabilità dei livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinate idroveicolato.
2.2 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità "media". Nelle zone definite a vulnerabilità media le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate di norma solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione di rischio di inquinamento e della predisposizione di accorgimenti tali da impedire l'arrivo di inquinanti idroveicolati in falda.
3. Salvaguardia dei punti di captazione ad uso acquedottistico. Nella QG.05 "Carta idrogeologica" del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, sono individuati con apposita simbologia grafica i principali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti sul territorio comunale. Con riferimento alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, ed al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, erogate mediante impianto di acquedotto, nonché per la tutela dello stato di salute delle risorse, sono altresì da identificarsi - con criterio geometrico - le seguenti aree di salvaguardia dei citati punti di captazione:
- - zone di tutela assoluta: aree di raggio pari a ml 10, immediatamente circostanti i punti di captazione o derivazione. Le "zone di tutela assoluta" devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. A tale scopo devono pertanto essere recintate, provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche, protette da esondazioni di corpi idrici limitrofi.
- - zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta, ed in assenza della individuazione da parte della Regione sono costituite dalle aree di raggio pari a ml 200 intorno ai punti di captazione o derivazione (queste ultime individuate con perimetrazioni in Carta idrogeologica - QG.05).
Le "zone di rispetto" dei punti di captazione ad uso acquedottistico sono sottoposte a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. All'interno di esse vengono in generale considerate come fattori potenziali di rischio, e pertanto vietate, le seguenti attività:
- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di un apposito piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
Per tali insediamenti ed attività, se preesistenti - ad eccezione delle aree cimiteriali - sono adottate misure per il loro allontanamento. In ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
4. Capacità di ricarica degli acquiferi. Nelle more dei piani di settore della AdB Distrettuale dell'Appennino Settentrionale risulta in vigenza (approvazione con D.P.C.M. del 20.02.2015 e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 07.07.2015) il "Piano Stralcio Bilancio Idrico". Lo stralcio "Bilancio Idrico" è lo strumento del Piano di Bacino per la definizione delle condizioni di criticità della risorsa idrica superficiale e sotterranea, e per l'imposizione di vincoli di sfruttamento sostenibile della stessa. Il bilancio idrico, definito alla scala del bacino idrografico, è espresso dall'equazione di continuità dei volumi entranti, uscenti ed invasati nel bacino superficiale e idrogeologico, al netto delle risorse necessarie per la conservazione degli ecosistemi acquatici ed dei fabbisogni per i diversi usi. È l'indispensabile strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa idrica nonché la base scientifica sulla quale costruire, all'interno dei Piani di Tutela, le analisi, gli studi previsionali e le strategie volte al perseguimento degli obiettivi di qualità e più in generale i programmi e le azioni di governo del territorio a scala poliennale.
Fornisce inoltre gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che sotterranei, in un quadro tecnico chiaro ed unitario.
In relazione a tale articolato sulla Carta Idrogeologica QG.05 sono riportati gli areale delle zone classificate:
- - Acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità molto inferiore alla ricarica (D4).
- 1. In tali aree sono vietati nuovi prelievi, con esclusione dei seguenti casi:
- a) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, possono essere rilasciate concessioni ad uso idropotabile, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- b) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, le concessioni per usi diversi da quello idropotabile sono rilasciate, a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area, l'essenzialità dell'uso, la mancanza di fonti alternative di approvvigionamento, l'efficienza dell'utilizzo nonché le misure di risparmio e riutilizzo adottate. In tali casi può essere chiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno", con obbligo di installazione di contatore;
- d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno", fino ad un valore di 100 m 3 /anno e con obbligo di installazione di contatore. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area e con obbligo di installazione di contatore.
- 2. In fase di rinnovo dei prelievi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- 3. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.
- 1. In tali aree sono vietati nuovi prelievi, con esclusione dei seguenti casi:
- - Acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità inferiore alla ricarica (D3).
- 1. Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessioni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei criteri sotto riportati:
- a) Le concessioni ad uso idropotabile possono essere rilasciate a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche ri portate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- b) le concessioni ad uso diverso da quello idropotabile possono essere rilasciate a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area e l'essenzialità dell'uso anche in relazione ai quantitativi idrici richiesti. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, fino ad un valore di 200 m 3 /anno. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area.
- 1. Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessioni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei criteri sotto riportati:
2. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.
CAPO 3 Norme Finali
Art. 70. Barriere architettoniche
1. Costituisce parte integrante del P.O. il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), allegato.
Art. 71. Edilizia sociale
1. Ai fini delle presenti norme si considera edilizia sociale ogni intervento di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzato:
- - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
- - a pratiche di affitto convenzionato e di vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- - a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
- - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.
2. Ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.
Art. 72. Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile
1. Le aree di emergenza individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile adottato con delibera di Giunta Comunale n.167 del 20.09.2023 (aree di attesa, aree di accoglienza e aree di ammassamento) devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.
2. Fatte salve diverse disposizioni del Piano comunale di protezione civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:
- - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- - interventi di nuova edificazione;
- - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- - depositi di merci e materiali a cielo libero;
- - altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.
Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.
Art. 73. Salvaguardie e norme transitorie
1. Le disposizioni indicate nelle correnti norme e negli elaborati che costituiscono il POC, fungono da salvaguardia fin dalla sua adozione.
2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino all'entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanistica in vigore o in salvaguardia.
3. Le misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del presente Piano Operativo non si applicano:
- a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme, se non in contrasto con il piano adottato.
- b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del P.O. medesimo.
4. L'entrata in vigore del Piano Operativo comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
5. I Permessi a costruire, i titoli abilitativi rilasciati (e le dichiarazioni di inizio attività che abbiano conseguito efficacia ) prima della data di adozione del P.O. rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, ma decadono laddove alla data di approvazione del P.O. i lavori non abbiano avuto inizio.
6. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale Intercomunale delle Città e territori delle due rive.
7. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme e le seguenti varianti al Regolamento Urbanistico:
- - Variante di minima entità al Piano Strutturale del Comune di Empoli, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/ 2013, contestualmente al secondo Regolamento Urbanistico per le previsioni ancora vigenti e non decadute;
- - Variante al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale, relativa alle aree produttive denominato #EMPOLIFAIMPRESA, limitatamente alle previsioni di nuova introduzione relative all'area Zignago, in variante allo strumento adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.90 del 19/11/2018, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19 aprile 2019;
- - Variane normativa al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 30 e 32 della l.r. 65/2014 per modifiche alle NTA, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/06/2022;
- - Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 238 della l.r. 65/2014, mediante approvazione del progetto definitivo denominato eco-park - rigenerazione urbana di fabbricato dismesso nel centro abitato di Ponte a Elsa, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 19/09/2022;
- - Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 238 della legge regione toscana n. 65/2014 e s.m.i. mediante approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta" e del progetto definitivo del nuovo tratto stradale di collegamento tra via Righi e via Galletti, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 25/11/2022;
- - Realizzazione del nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via R. Sanzio a Empoli - primo stralcio. Variante al RU, mediante approvazione del progetto definitivo di cui all'art. 34 della lrt 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2023;
- - Rigenerazione urbana del complesso di piazza Guido Guerra, con realizzazione del nuovo teatro comunale - progetto di fattibilità tecnico economica in variante al Regolamento Urbanistico, con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 10/05/2023.Per l'ambito OP5 individuato dalla Scheda Norma R.1 valgono le disposizioni ivi contenute, sulle aree esterne all'ambito OP5 e ricomprese nell'Ambito R1 si applicano le misure del Piano adottato.
- - Variante per interventi puntuali all'interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 25/11/2019;
- - Variante al PS e al RU vigente ai sensi dell'art. 238 e 252ter della LRT 65/2014, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 18 dicembre 2023;
8. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.
9. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri atti abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Piano Operativo e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
10. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l'integrità delle risorse e la difesa dal rischio:
- - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
- - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
- - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
- - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.
11 Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.
12. I vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica. Qualora sia previsto che l'opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.
13. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui sopra si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d) dell'art.95 della L.R.65/2014, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.
Tabella A Elenco delle funzioni
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.1.1 | Industriale e manifatturiera |
Attività produttiva di tipo industriale e di trasformazione di prodotti di tipo industriale,
Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi esclusivamente relativa alla giacenza e/o messa in riserva, selezione e cernita manuale e/o meccanica e senza alcuna attività di smaltimento. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi
|
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.1.2 | Artigianale, meccanica e tecnologica |
Attività produttiva artigianale non insalubri con emissioni trascurabili o limitate, di tipo meccanico, tecnologico, di trasformazione o assemblaggio di prodotti. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale prevalente, sono compresi
|
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.1.3 | Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza | Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, elettrauto, distribuzione carburanti, autolavaggi falegnamerie, manifattura artigiana, e comunque con emissioni tendenzialmente moleste, compresi i relativi uffici amministrativi. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.1.4 | Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza | Attività di trasformazione diretta alla produzione di beni specifici, senza emissioni tendenzialmente moleste, quali gelaterie, panetterie, pasta fresca, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, ceramisti, e comunque tutte quelle non assimilabili all’attività di servizio alla persona e alle imprese. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.1.5 | Industriale e manifatturiera specializzata |
Attività di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi. Sono compresi le attività che comportano operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici con l’esclusione di qualsiasi operazione di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l’incenerimento. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi
|
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.2.1 | Esercizi di vicinato e media distribuzione |
Attività di commercio per la vendita di generi alimentari e non alimentari, dagli esercizi al dettaglio fino alle medie strutture di vendita, compresi i relativi uffici amministrativi Sono da intendersi compresi l’attività di vendita di autoveicoli, motoveicoli e similari il noleggio di mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.3.1 | Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere | Alberghi, hotel, motel e villaggi albergo e residenze speciali per studenti, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale convegni, spazi comuni funzionalmente connessi con l’attività principale. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.4.2 | Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative |
Impianti per la produzione, fornitura e distribuzione di energia Impianti per la fornitura e distribuzione di acqua, compresi:
|
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.4.3 | Impianti senza presidio di unità lavorative | Impianti tecnologici puntuali |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.4.4 | Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione | Complessi direzionali e sedi bancarie, assicurative e finanziarie, i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazioni, call center, centri elaborazioni dati, centri di ricerca, tutte strutturate in edifici monofunzionali. Compresi i relativi depositi, archivi e spazi comuni. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.4.5 | Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese | Attività di servizio quali lavanderie e stirerie non industriali, sartorie e similari, calzolai, tappezzerie, botteghe di restauro mobili, corniciai, assistenza e riparazione beni personali e per la casa, orafi, laboratori artigianali artistici, toilette per animali, officine di riparazione, cicli e motocicli, parrucchieri, centri estetici e benessere, laboratori fotografici, agenzie di viaggio, biglietterie e box-office, internet point, agenzie ippiche, sale scommesse, onoranze funebri e noleggio beni di consumo. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.4.6 | Terziario di tipo diffuso – attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati | Uffici e studi professionali, sportelli bancari, ambulatori e studi medici, agenzie d’affari ed immobiliari, centri di riabilitazione fisioterapica, laboratori di analisi, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.4.7 | Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere | Ristorazione e mense aziendali. |
| F.4.8 | Sale convegni, attrezzature culturali, per il tempo libero, cinema, discoteche, sale giochi, servizi per attività sportive quali campi da tennis e calcetto in strutture al coperto, servizi per il benessere fisico e la cura della persona (palestre, fitness, centri benessere, scuole di danza e ballo, ecc.). | |
| F.4.9 | Scuole professionali private, asili aziendali e interaziendali, autoscuole, e similari. |
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.5.1 | Commercio all’ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza Attività di stoccaggio di merci, deposito e magazzinaggio sia al chiuso che all’aperto, di materie prime, semilavorate e/o prodotti finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi e loro rivendita a categorie quali commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità e loro consorzi, con l’esclusione di qualsiasi forma di commercializzazione al dettaglio. |
Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi
|
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.5.2 | Depositi e logistica indoor |
Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente al chiuso. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi
|
| Funzione | Usi compatibili | |
|---|---|---|
| F.5.3 | Logistica a cielo libero |
Attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse. Svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio esclusivamente all’aperto su piazzali. Esclusivamente nel caso di categoria funzionale monofunzionale o prevalente, sono compresi:
|