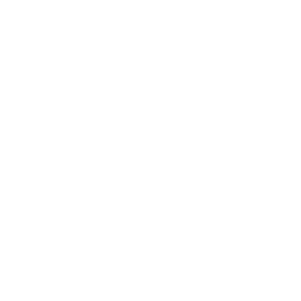Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 65. Disposizioni generali
1. Generalità. La disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio di cui al presente "capo" recepisce le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale, piani di settore e atti di governo del territorio dei diversi soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica, idrogeologica e sismica di cui a:
- - DPGR 5/R del 30.01.2020;
- - LR 41/2018;
- - DLgs 152/ 2006 con particolare riferimento alla Parte III;
- - Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Firenze di cui alla DCP n. 1/2013 di approvazione della variante di adeguamento del PTCP ai sensi dell'art.17 della LR 1/2005;
- - Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA);
- - Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI);
- - Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno;,
- - Progetto di Piano del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto PAI Dissesti geomorfologici);
- - Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA);
- - Piano di Bacino stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI);
coordinandole con la normativa urbanistico-edilizia e con le previsioni di cui al presente Piano Operativo.
Ogni modifica e/o integrazione alle disposizioni di cui agli strumenti sovraordinati approvati successivamente all'entrata in vigore del presente Piano Operativo è oggetto di adeguamento approvato con presa d'atto del Consiglio Comunale.
2. Elaborati di riferimento. Costituiscono oggetto dell'articolazione normativa del presente Piano Operativo:
- -la disciplina finalizzata alla salvaguardia e riduzione del rischio idraulico;
- -le disposizioni finalizzate alla protezione e al governo della risorsa idrica;
- -le disposizioni finalizzate alla salvaguardia e riduzione dei rischi geologico e sismico;
- -i criteri di fattibilità da applicarsi agli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nelle aree con pericolosità geologica, idraulica e sismica contenuti nelle singole schede norma sulla base degli interventi ivi previsti.
Tali disposizioni, criteri, condizioni e prescrizioni di fattibilità assumono valenza prescrittiva.
La presente disciplina si pone in diretta relazione con i contenuti dei seguenti elaborati del "Piano Strutturale Intercomunale delle due rive", allestiti per il territorio comunale di Empoli:
- -Elaborato QG.03 - Carta idrogeologica e vulnerabilità degli acquiferi;
- -Elaborato QG.04 - Carta della pericolosità geologica;
- -Elaborato QG.05 - Carta della pericolosità sismica;
- -Elaborato QI.06d_Magnitudo idraulica
- -Elaborato QI.07d_Proposta di modifica al Piano Gestione Rischio Alluvioni
3. Criteri di fattibilità. I criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, al rischio di alluvioni, a problematiche connesse alla risorsa idrica e in relazione agli aspetti geologici per gli interventi previsti/ammessi dal Piano Operativo sono definiti sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 e sulla scorta dei principi generali fissati dal Piano Strutturale Intercomunale, quali indirizzi per il Piano Operativo.
I criteri di fattibilità individuati in relazione agli aspetti sismici sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale Intercomunale, oltre ad essere conformi alle prescrizioni generali della normativa regionale vigente (ex paragrafo C.3 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020), recepiscono anche gli studi di microzonazione sismica effettuati per il Comune di Empoli (Microzonazione Sismica MS1 e MS2 facenti parte del quadro conoscitivo), che hanno portato alla mappatura del fattore di amplificazione sismica su vasti areali che includono tutti i territori urbanizzati del territorio comunale.
I criteri di fattibilità degli interventi ordinari relativi al patrimonio edilizio esistente ed alle infrastrutture, che non siano soggetti nelle "schede norma" del presente Piano Operativo devono essere definiti, secondo quanto disposto al paragrafo 3 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale Intercomunale. Per edifici e/o infrastrutture ricadenti in classi di pericolosità differenti deve essere considerata quella più elevata o comunque quella finalizzata ad ottenere condizioni maggiormente cautelative.
I criteri di fattibilità degli interventi disciplinati con apposita scheda norma (ID, PUC, PUA-RQ ,PUA -AT*e OP) sono individuati nella specifica sezione criteri di fattibilità e prescrizioni; per gli interventi che trovano attuazione attraverso l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi, i criteri di fattibilità devono essere ridefiniti sulla base di considerazioni di maggior dettaglio derivanti da appositi studi (campagne di indagini geognostiche mirate alla situazione sitospecifica, modellazioni idrauliche sulla base della proposta progettuale, ecc). Le limitazioni ed i condizionamenti individuati si aggiungono e non sostituiscono quelli determinati dalle normative di settore.
Su tutto il territorio comunale sono consentiti interventi funzionali a ridurre il livello di pericolosità territoriale e conseguentemente a rivalutare la possibilità di modifica dei criteri di fattibilità a condizione che non aggravino la condizione delle aree contermini o comunque correlate.
Le prescrizioni relative ai criteri di fattibilità sono state schematizzate e distinte in relazione ai 4 aspetti: geologico, idraulico, sismico e tutela della risorsa idrica sotterranea (idrogeologico).
Art. 66. Criteri di fattibilità e prescrizioni in relazione agli aspetti geologici
1. Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020.
2. Classificazione delle aree a pericolosità geologica. L'attribuzione delle classi di pericolosità geologica è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione geologica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale.
Per la comprensione della nomenclatura in uso per la classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica nei disposti normativi in vigenza di cui al:
- -PAI del bacino dell'Arno (AdB);
- -PAI del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale Distrettuale (ADAS);
- -DPGR 53/R/2011;
- -DPGR 5/R/2020;
si riporta il seguente schema esemplificativo con la sintetica identificazione della classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione, susseguitasi nel tempo, nei vari disposti normativi.
| Abaco della Pericolosità geologica/geomorfologica nell'evoluzione della normativa sovracomunale | |||
|---|---|---|---|
| DPGR. n. 53/R/2011 | DPGR. n. 53/R/2020 | PAI AdB Arno | PAI Distretto App Sett. |
| G.4 (molto elevata) | G.3 (elevata) | G.2 (media) | G.1 (bassa) |
| G.4 (molto elevata) | G.3 (elevata) | G.2 (media) | G.1 (bassa) |
| P.F.4 (molto elevata) | P.F.3 (elevata) | P.F.2 (media) | P.F.1 (bassa) |
| P.4 (molto elevata) | P.3 (elevata) | P.2 (media) | P.1 (bassa) |
Nella tavola QG.04 Pericolosità geologica del Piano Strutturale Intercomunale sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle classi di pericolosità geologica ai sensi del DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1.
3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica molto elevata G4. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.1 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 10 delle Norme di Piano ed Allegati del PAI Arno).
3.1 Fattibilità G4 | nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione, (ai sensi della LR 41/2018) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio tesi alla riduzione della pericolosità e/o alla mitigazione del rischio. Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 e devono esser tali da:
- -non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- -non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- -consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza deve essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e l'Ente sovracomunale preposto al controllo.
Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.
3.2 Fattibilità G4 | altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:
- -la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- -gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- -la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso;
- -l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell'importanza dell'opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle caratteristiche del dissesto attivo in atto.
3.3 Fattibilità G4 | scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell'area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.
4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A al DPGR n. 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 11 delle Norme di Piano ed Allegati del PAI Arno).
4.1 Fattibilità G3 | nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione (ai sensi del DPGR 5r/2020) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità da effettuarsi in fase di pianificazione attuativa o di presentazione di progetto per il rilascio del titolo abilitativo.
Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l'esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio, tesi a verificare l'efficacia degli stessi.
Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e devono essere tali da:
- - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
- - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza dovrà essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e l'Ente sovracomunale preposto al controllo.
Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi.
4.2 Fattibilità G3 | altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:
- - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- - la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso;
- - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell'importanza dell'opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle sue caratteristiche in relazione alla possibilità potenziale di esposizione al dissesto.
4.3 Fattibilità G3 | scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico, da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell'area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.
5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica media G2. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.3 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 12 delle Norme di Piano ed Allegati del PAI Arno).
5.1 Fattibilità G2 | nuova costruzione/altri interventi. La fattibilità degli interventi di:
- - nuova costruzione (ai sensi della LR 41/2018);
- - nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- - incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- - ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d'uso;
- - ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è condizionata alle risultanze di specifiche indagini geologiche, geognostiche e geofisiche da eseguirsi in fase progettuale, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.
6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica bassa G1. Sono consentite tutte le tipologie di intervento, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
7. Direttive per la formazione dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e dei progetti edilizi. I Piani Attuativi, i Piani di Recupero, i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), le attività permesse nelle aree di trasformazione e i progetti edilizi, fatte salve ulteriori ed eventuali prescrizioni contenute nel Piano Strutturale o nel presente Piano Operativo, devono essere corredati di elaborati geologici, geotecnici e di modellazione sismica contenenti gli esiti di apposite indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da effettuare in relazione alla classe di indagine in cui ricade l'intervento, così come definita al paragrafo 3 dell' Allegato 1 - art. 5 DPGR 1/R/2022.
Art. 67. Fattibilità per fattori idraulici
1. Criteri di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.3 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020 Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni.

1.1 Modellazione idraulica. I livelli idraulici di riferimento per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico e per l'eventuale programmazione/progettazione degli interventi di messa in sicurezza e/o riduzione del rischio, devono essere acquisiti dagli studi di modellazione quantitativa del Piano Strutturale (tavole con indicazione di pericolosità idraulica, battenti di esondazione per Tr 200 anni e magnitudo idraulica del reticolo oggetto di studio), fatto salvo eventuali studi successivi sostitutivi o integrativi, rispetto a quelli impiegati per le elaborazioni del Piano Strutturale Intercomunale e del presente Piano Operativo.
1.2 Tempo di ritorno TR 200. Ogni considerazione in relazione a valutazioni di rischio ed azioni finalizzate alla sua riduzione per la definizione dei criteri di fattibilità, deve avere a riferimento l'evento ricorrente con tempo di ritorno Tr 200 anni.
1.3 Gestione-riduzione del rischio/messa in sicurezza. Nella progettazione degli interventi di gestione del rischio, riduzione del rischio idraulico e/o messa in sicurezza si deve operare tenendo conto di un franco di sicurezza rispetto al livello idraulico di riferimento (battente di piena per Tr 200 anni) come sotto definito:
- a) per le aree esondabili da parte di corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale 0,50 ml;
- b) per le aree esondabili da parte dei corsi d'acqua afferenti al reticolo secondario 0,30 ml.
In caso di area interessata sia da eventi derivanti dal reticolo principale, sia da reticolo secondario, la sicurezza idraulica deve essere garantita rispetto al più gravoso dei due scenari.
2. Classificazione delle aree a pericolosità da alluvioni. L'attribuzione delle classi di pericolosità da alluvioni è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione idrologico idraulica (quadro conoscitivo del PSI) redatta a compendio degli studi di modellazione quantitativa a supporto del Piano Strutturale Intercomunale e conforme ai criteri del comma C.2 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020.
2.1 Magnitudo idraulica. La LR 41/2018 introduce, all'art. 2, lettere h1, h2 e h3, il concetto di magnitudo idraulica, quale criterio per la valutazione di fattibilità idraulica in relazione alla gestione del rischio idraulico.
Si riporta il seguente schema esemplificativo relativo alla determinazione della classe di magnitudo idraulica in funzione della determinazione o meno della velocità della corrente.
Schema delle magnitudo
3. Fattibilità in aree classificate a rischio di alluvioni. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla LR 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
4. Direttive per la formazione dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e dei progetti edilizi. I Piani Attuativi, i Progetti Unitari Convenzionati e i progetti edilizi ricadenti in aree a pericolosità per alluvioni frequenti e/o poco frequenti, devono essere corredati da specifici elaborati grafici riportanti planimetrie e sezioni/prospetti in cui sia individuata, in termini di quote assolute (m slm), la quota di sicurezza idraulica per Tr 200 anni, oltre il relativo franco di sicurezza definito al punto 1.3 del presente articolo.
4.1 Modellazione idrologico idraulica. Il livello idraulico di riferimento ai fini della progettazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica deve essere derivato dagli studi di modellazione idrologico idraulica del quadro conoscitivo del PSI, salvo eventuali studi successivi sostitutivi o integrativi validati/approvati dalle autorità competenti.
4.2 Sistema di riferimento altimetrico (LIDAR). Le proposte progettuali e/o le modellazioni idrauliche quantitative devono basarsi su dati altimetrici, individuati su cartografia Lidar, se disponibile, o su dati altimetrici derivanti da specifici rilievi di cui ne sia verificata la coerenza plano altimetrica con la cartografia Lidar.
5. Misure per la riduzione della pericolosità da alluvioni e della magnitudo. La gestione del rischio di alluvioni, finalizzata al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 e il non aggravio delle condizioni di rischio idraulico, devono essere assicurati mediante la realizzazione delle opere di cui all'art. 8 della LR41/2018. Per maggiori dettagli tecnici sulla definizione delle condizioni di rischio R2 (in particolare per parcheggi e infrastrutture di viabilità) si rimanda alla relazione di fattibilità geologica ed idraulica a supporto del PO.
6. Fattibilità in aree non soggette a rischio alluvioni. Ad interventi e previsioni esterni ad aree classificate a pericolosità da alluvioni non si attribuiscono prescrizioni specifiche per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo opportune indicazioni di misure per il riordino o ripristino del drenaggio superficiale.
7. Fattibilità in aree presidiate da sistemi arginali non soggette a rischio alluvioni. Nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, così come definite nella LR 41/2018 art. 2 lettera s, per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale. A tal fine il Comune, entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.
8. Fattibilità nelle aree di contesto fluviale. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10m dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, come definito ed individuato dalla LR 79/2012, la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla LR 41/2018 e nel rispetto della normativa di settore sovraordinata R.D. n. 523/1904.
9. Fattibilità nelle aree di fondovalle fluviale. Nelle aree di fondovalle fluviale evidenziate nelle tavole di Piano Strutturale la fattibilità degli interventi è condizionata alla realizzazione di studi idraulici con grado di dettaglio adeguato ad individuare il livello di rischio dell'area di intervento.
10. Invarianza idraulica a seguito dell'impermeabilizzazione dei suoli. Nell'ambito di Piani Attuativi, Piani di Recupero, Progetti Unitari Convenzionati e progetti di opere pubbliche comportanti incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà essere prevista la realizzazione di idonei sistemi di laminazione, volti a garantire l'invarianza tra le condizioni ante e post opera della portata massima in uscita dalla rete di raccolta acque meteoriche dell'area di trasformazione, sia essa costituita da sistemi di fognatura o dal reticolo idrografico minore. L'invarianza idraulica dovrà essere valutata con riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno ventennale (Tr20) e durate di pioggia rappresentative per il caso in esame, facendo riferimento a metodi di calcolo di adeguato grado di dettaglio per la tipologia di intervento in esame. Il presente comma trova applicazione anche ad interventi di edilizia diretta comportanti un ampliamento della superficie impermeabile superiore del 30% rispetto allo stato ante intervento.
Art. 68. Fattibilità per fattori sismici
1. Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.6 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020.
2. Classificazione delle aree a pericolosità sismica. L'attribuzione delle classi di pericolosità sismica è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione geologica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale e comunque conforme ai criteri dettagliati al paragrafo C.3 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020. Tali valutazioni sono basate sugli esiti degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 e 2 elaborati a compendio del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi del DPGR 5/R/2020.
3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica molto elevata S4. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S4, già in fase di Piano Operativo debbono essere svolti studi di approfondimento di cui al dettaglio dei paragrafi 3.2.1 e 3.6.1 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020. Tutti gli interventi consentiti, indipendentemente dalla modalità attuativa (PA, PUC, ecc), devono essere sottoposti a studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento, per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica.
3.1 Classe S4 | nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione in aree di instabilità di versante attive, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo quanto stabilito ai paragrafi 3.6.2 e 3.2.1, lettera a dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 come specificato al comma 3.1 dell'art. 66 della presente disciplina.
3.2 Classe S4 | altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:
- -la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- -gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- -l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; relativamente alle aree di instabilità di versante attive è subordinata all'applicazione dei criteri definiti al paragrafo 3.2.1 lettera b dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 come dettagliato anche al comma 3.2 dell'art. 66 delle presenti norme, nonché all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4);
- -la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatti salvi quelli che non incidono sulle parti strutturali degli edifici e fatti salvi gli interventi di riparazione o locali (NTC18, punto 8.4.3), è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).
3.3 Interventi non condizionati. Sono consentiti, in aree classificate a pericolosità sismica S4, senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica elevata S3, S3f e Slq. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S3 si applicano i criteri di fattibilità previsti ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020.
4.1 Classe S3f | nuova costruzione. Nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità S3f), la fattibilità degli interventi di nuova costruzione è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020. Come dettagliato al comma 4.1 dell'art. 66 delle presenti norme, gli studi sono commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento (DPGR 1/R/2022) e finalizzati all'elaborazione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto anche dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'ODPCM 3907/2010.
4.2 Classe S3f | altri interventi. Nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità S3f), la fattibilità degli interventi che interessano:
- - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
- - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
- - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;
è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020. Come dettagliato al comma 4.2 dell'art. 66 delle presenti norme, gli studi sono commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento (DPGR1/R/2022) e finalizzati, alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, tenendo conto anche dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
4.3 Classe S3lq. Nelle aree con presenza di terreni potenzialmente suscettibili di liquefazione dinamica (classe di pericolosità S3lq), per i quali sulla base delle informazioni disponibili non sia stato possibile escludere a priori il rischio di liquefazione negli studi MS2, si prescrive che vengano realizzate indagini geognostiche sitospecifiche e svolte considerazioni geotecniche per il calcolo del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni in maniera sistematica sull'estensione di verticali da accertare mediante indagini puntuali per la definizione dell'Indice del potenziale di liquefazione, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione" - LIQ, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'o.d.p.c.m.3907/2010, atte e finalizzate alla verifica e al confronto con i valori dell'indice di liquefazione derivati e desunti dagli studi di Microzonazione Sismica di livello 2.
Si prescrive che le verifiche di cui sopra debbano essere realizzate con approfondimenti geognostici in sito da eseguirsi già in fase di Piano Attuativo e/o PUC (ove questi strumenti di attuazione sia previsti) o, in loro assenza, in fase di progettazione edilizia (rilascio di permesso di costruire, approvazione di opera pubblica, SCIA, ecc), ad integrazione di quanto codificato a livello di NTC_2018 e DPGR n. 1/R/2022, secondo le casistiche di cui al dettaglio che segue:
- - per edifici in classe di indagine 2 (DPGR n. 1/R/2022) mediante prove CPT;
- - per edifici in classe di indagine 3 e 4 (DPGR n. 1/R/2022) mediante prove CPTU e valutazioni qualitative basate su fusi granulometrici.
In caso siano verificate condizioni di rispetto e/o suscettibilità per liquefazione per IL > 5 , la fattibilità è subordinata alla realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica dei terreni in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione", da progettare in funzione degli esiti delle verifiche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell'Indice del potenziale di liquefazione).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali interventi potranno essere realizzati mediante: incremento della densità del terreno, compattazione del terreno, riduzione del grado di saturazione con incremento delle pressioni efficaci, dissipazione e controllo della pressione dell'acqua, controllo della deformazione al taglio e dell'eccesso di pressione neutra.
4.4 Classe S3 | campagna di indagini. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità S3), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 o 3 (FA_0.1-0.5>1,4), la fattibilità di ogni intervento è subordinata agli esiti di una specifica campagna di indagini geofisiche individuate sulla base del contesto sismostratigrafico dell'area derivante dagli studi di microzonazione sismica (profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro, MASW, ESAC, HVSR, ecc) e geognostiche (sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo, CPT, DPSH, ecc), che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l'entità del/dei contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordo valle è necessaria, in aggiunta, una ricostruzione bidimensionale con prove geofisiche di superficie del tipo sismica a rifrazione o a riflessione.
4.5 Classe S3, S3f, S3lq | patrimonio edilizio esistente. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in aree classificate in classe di pericolosità sismica S3, S3f e S3lq) è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4. Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici.
4.6 Classe S3 / Edifici strategici, rilevanti e adibiti a pernottamento. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità S3 per amplificazione stratigrafica), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 (FA_0.1-0.5>1,4), la fattibilità degli interventi di realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti nelle classe d'indagine 3 o 4 (DPGR 1/R/2022) e di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4 (DPGR 1/R/2022), come definite dal regolamento di attuazione di cui al DPGR 1/R/2022 è subordinata alla valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, mediante specifiche analisi di risposta sismica locale RSL (in conformità NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione.
4.7 Interventi senza condizioni. Sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica media S2. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S2 si applicano le condizioni di fattibilità previste al paragrafo 3.6.5 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020.
6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica bassa S1. Sono consentite tutte le tipologie di intervento senza specifici condizionamenti per la fase attuativa e/o per la valida formazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.
Art. 69. Fattibilità connessa alla risorsa idrica
1. Criteri generali di fattibilità connessi a problematiche inerenti la risorsa idrica.
I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.5 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020, fatto salvo i disposti normativi dei piani sovraordinati.
1.1 Uso della risorsa idrica. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:
- - allacciamento alla rete acquedottistica;
- - preventiva valutazione del fabbisogno idrico e contestuale verifica di sostenibilità con l'Ente Gestore per gli interventi relativi alle aree di trasformazione che prevedano nuovi insediamenti;
- - riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione dei tratti della rete, sulla base delle valutazioni dell'Ente Gestore nell'ambito dell'attuazione dei propri interventi;
- - massimizzazione della raccolta e reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- - utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;
- - recupero e riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.
1.2 Qualità della risorsa. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:
- - l'allacciamento all'infrastruttura fognaria; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;
- - l'adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o nel caso sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo.
1.3 Opere interrate e interferenze con la falda. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sulle acque sotterranee connesso a nuove infrastrutture interrate, volumi interrati nonché opere strutturali e fondali che possano interagire con la falda, deve essere predisposto un appropriato quadro conoscitivo sitospecifico ante operam, che contenga i dati idrogeologici di sito necessari per delineare la fattibilità dell'intervento sia in fase di corso d'opera che in fase post opera, ed individuare eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell'ottica della tutela della risorsa stessa. Per gli interventi che prevedono strutture sotterranee di rilevanza (parcheggi interrati multi piano, opere di presidio di fronti di scavo, sottopassi e tunnel ecc.) in fase di progettazione devono essere condotti specifici studi per la valutazione dell'impatto sulla dinamica di flusso della falda e sulla qualità della risorsa. Tali studi si basano su una modellazione idrogeologica delle modifiche correlabili alle configurazioni dello stato ante operam, durante la gestione di cantiere, post operam, con riferimento inoltre a modifiche dei livelli di falda anche in relazione alle opere circostanti.
Al verificarsi di situazioni di significative interferenze idrogeologiche si deve provvedere alla progettazione di specifiche opere di mitigazione.
2. Criteri di fattibilità in relazione alle condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. La classificazione di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea è definita nella "Carta idrogeologica" (tavv. QG.03) facente parte del quadro conoscitivo del PSI.
2.1 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità "molto elevata" e "medio elevata". In tali aree si prescrive, in linea di massima, che venga escluso l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U.; stoccaggio di sostanze inquinanti; depuratori; depositi di carburanti; pozzi neri a dispersione; spandimenti di liquami, etc.
Le fognature dovranno essere realizzate con manufatti e/o sistemi che garantiscano dallo sversamento di reflui nel terreno. Sono fatti salvi aggiornamenti legislativi in merito.
Deroghe a queste linee di indirizzo potranno essere realizzate nel caso che:
- - si dimostri la necessita, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare comunque la previsione in tali zone;
- - vengano eseguite specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde; a tal fine dovranno essere misurate le permeabilità dei livelli posti al di sopra dell'acquifero, calcolando sperimentalmente il "tempo di arrivo" di un generico inquinate idroveicolato.
2.2 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità "media". Nelle zone definite a vulnerabilità media le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate di norma solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione di rischio di inquinamento e della predisposizione di accorgimenti tali da impedire l'arrivo di inquinanti idroveicolati in falda.
3. Salvaguardia dei punti di captazione ad uso acquedottistico. Nella QG.05 "Carta idrogeologica" del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale, elaborata su base C.T.R. in scala 1:10.000, sono individuati con apposita simbologia grafica i principali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti sul territorio comunale. Con riferimento alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, ed al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, erogate mediante impianto di acquedotto, nonché per la tutela dello stato di salute delle risorse, sono altresì da identificarsi - con criterio geometrico - le seguenti aree di salvaguardia dei citati punti di captazione:
- - zone di tutela assoluta: aree di raggio pari a ml 10, immediatamente circostanti i punti di captazione o derivazione. Le "zone di tutela assoluta" devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. A tale scopo devono pertanto essere recintate, provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche, protette da esondazioni di corpi idrici limitrofi.
- - zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta, ed in assenza della individuazione da parte della Regione sono costituite dalle aree di raggio pari a ml 200 intorno ai punti di captazione o derivazione (queste ultime individuate con perimetrazioni in Carta idrogeologica - QG.05).
Le "zone di rispetto" dei punti di captazione ad uso acquedottistico sono sottoposte a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. All'interno di esse vengono in generale considerate come fattori potenziali di rischio, e pertanto vietate, le seguenti attività:
- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di un apposito piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
Per tali insediamenti ed attività, se preesistenti - ad eccezione delle aree cimiteriali - sono adottate misure per il loro allontanamento. In ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
4. Capacità di ricarica degli acquiferi. Nelle more dei piani di settore della AdB Distrettuale dell'Appennino Settentrionale risulta in vigenza (approvazione con D.P.C.M. del 20.02.2015 e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 07.07.2015) il "Piano Stralcio Bilancio Idrico". Lo stralcio "Bilancio Idrico" è lo strumento del Piano di Bacino per la definizione delle condizioni di criticità della risorsa idrica superficiale e sotterranea, e per l'imposizione di vincoli di sfruttamento sostenibile della stessa. Il bilancio idrico, definito alla scala del bacino idrografico, è espresso dall'equazione di continuità dei volumi entranti, uscenti ed invasati nel bacino superficiale e idrogeologico, al netto delle risorse necessarie per la conservazione degli ecosistemi acquatici ed dei fabbisogni per i diversi usi. È l'indispensabile strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa idrica nonché la base scientifica sulla quale costruire, all'interno dei Piani di Tutela, le analisi, gli studi previsionali e le strategie volte al perseguimento degli obiettivi di qualità e più in generale i programmi e le azioni di governo del territorio a scala poliennale.
Fornisce inoltre gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che sotterranei, in un quadro tecnico chiaro ed unitario.
In relazione a tale articolato sulla Carta Idrogeologica QG.05 sono riportati gli areale delle zone classificate:
- - Acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità molto inferiore alla ricarica (D4).
- 1. In tali aree sono vietati nuovi prelievi, con esclusione dei seguenti casi:
- a) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, possono essere rilasciate concessioni ad uso idropotabile, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- b) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, le concessioni per usi diversi da quello idropotabile sono rilasciate, a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area, l'essenzialità dell'uso, la mancanza di fonti alternative di approvvigionamento, l'efficienza dell'utilizzo nonché le misure di risparmio e riutilizzo adottate. In tali casi può essere chiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno", con obbligo di installazione di contatore;
- d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno", fino ad un valore di 100 m 3 /anno e con obbligo di installazione di contatore. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area e con obbligo di installazione di contatore.
- 2. In fase di rinnovo dei prelievi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- 3. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.
- 1. In tali aree sono vietati nuovi prelievi, con esclusione dei seguenti casi:
- - Acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità inferiore alla ricarica (D3).
- 1. Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessioni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei criteri sotto riportati:
- a) Le concessioni ad uso idropotabile possono essere rilasciate a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche ri portate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- b) le concessioni ad uso diverso da quello idropotabile possono essere rilasciate a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area e l'essenzialità dell'uso anche in relazione ai quantitativi idrici richiesti. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 delle "Misure di Piano del Piano Stralcio Bilancio Idrico della AdB Fiume Arno";
- d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, fino ad un valore di 200 m 3 /anno. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area.
- 1. Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessioni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei criteri sotto riportati:
2. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.